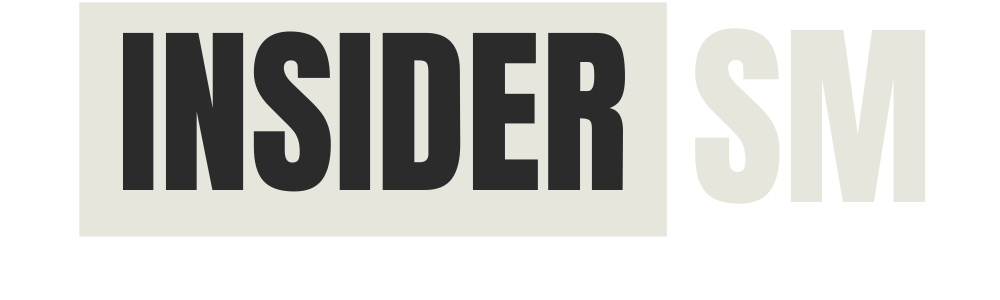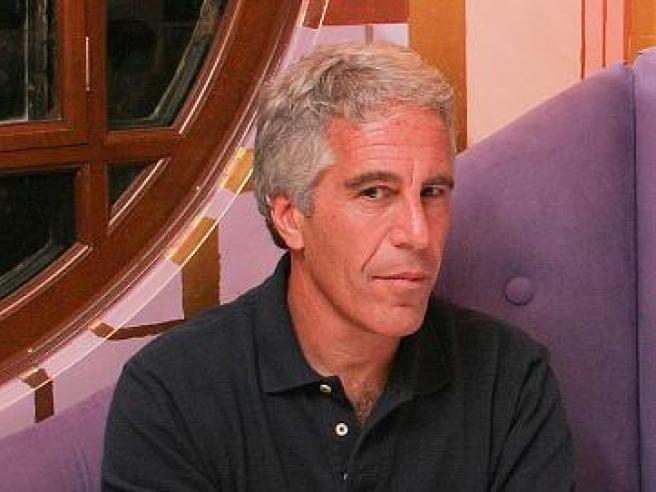La seduta della Commissione si concentra fin dalle prime battute sull’avvio dell’esame del progetto di legge “Indicatore della Condizione Economica per l’Equità – ICEE”, segnando l’inizio del confronto politico su uno degli strumenti destinati a ridefinire l’accesso alle prestazioni e ai contributi sociali. Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi introduce il testo sottolineando che l’ICEE arriva in Commissione come legge e non come decreto da ratificare, per favorire una discussione preventiva più ampia. Precisa inoltre che l’applicativo informatico è già in fase avanzata di sperimentazione e che, grazie alla collaborazione con l’Associazione Bancaria Sammarinese, è stata integrata la componente dei dati bancari nazionali, rendendo la piattaforma pronta all’operatività.
Belluzzi spiega che l’indicatore economico non avrà effetti vincolanti immediati, ma sarà introdotto attraverso una fase di sperimentazione finalizzata a raccogliere dati e correggere eventuali distorsioni. Alcuni emendamenti presentati dallo stesso Segretario prevedono l’avvio di una fase transitoria con articoli dedicati, durante la quale verranno coinvolti soggetti istituzionali e sociali per definire soglie e fasce di accesso ai futuri benefici. Particolare attenzione viene posta sul tema dei patrimoni immobiliari, con la necessità di armonizzare i dati tra beni detenuti in Repubblica e all’estero, in assenza di un Catasto omogeneo.
Il dibattito tra i commissari mette subito in luce visioni differenti. Emanuele Santi (Rete) definisce l’ICEE uno strumento atteso ma insufficiente, criticando il rinvio eccessivo a regolamenti del Congresso, il tempismo rispetto alla riforma IGR e il rischio di elusione tramite trust, società immobiliari e beni esteri. Chiede inoltre che la precompilazione dei dati già in possesso della PA sia prevista da subito.
Carlotta Andruccioli (Domani Motus Liberi) apprezza che l’ICEE sia arrivato in forma di legge, ma ritiene che il testo sia troppo “vuoto”, poiché parametri e criteri di calcolo vengono demandati ai regolamenti. Maria Katia Savoretti (Repubblica Futura), pur sostenendo il provvedimento, esprime le stesse perplessità e segnala che la versione attuale del testo è molto diversa da quella presentata in prima lettura. Solleva inoltre attenzioni sulla privacy e sulla compatibilità con altri ambiti come diritto allo studio e servizi sanitari.
Sul fronte della maggioranza, Marco Mularoni (PDCS) respinge l’idea che l’ICEE sia un provvedimento “vuoto” e ricorda che lo strumento nasce da un percorso lungo diverse legislature. Invita a non pretendere la perfezione da una misura che nasce in forma sperimentale e difende l’uso dei regolamenti per garantire maggiore flessibilità.
Giuseppe Maria Morganti (Libera) sottolinea che l’ICEE rappresenta un passaggio fondamentale per superare la distribuzione “a pioggia” delle risorse pubbliche, mentre Enrico Carattoni (Repubblica Futura) richiama l’attenzione sul perimetro della sperimentazione e chiede chiarezza sull’impatto futuro dell’indice su sanità e servizi sociosanitari, criticando la delegificazione eccessiva verso il Congresso. In chiusura, Gemma Cesarini (Libera) precisa che l’obbligo di dichiarare i redditi ovunque prodotti esiste già nella normativa fiscale, inclusi quelli derivanti da trust, ma riconosce che occorrono controlli più efficaci.
Al termine del dibattito generale, il Segretario Belluzzi richiede una sospensione dei lavori per un confronto sugli emendamenti. La seduta viene aggiornata nel pomeriggio, con l’esame degli articoli ancora da avviare.
Di seguito il report integrale
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA
Lunedì 20 ottobre, mattina
la Commissione si apre con il comma dedicato alle “comunicazioni”. Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi annuncia il deposito imminente della relazione sull’accordo di associazione con l’Unione Europea e sottolinea che la preparazione della pubblica amministrazione è una priorità fin dall’inizio del suo mandato. Ricorda i percorsi avviati sulla formazione, anche con il coinvolgimento dell’Università, e cita iniziative legate al riconoscimento dei titoli e alla partecipazione a Erasmus.
Maria Katia Savoretti (Repubblica Futura) accoglie positivamente l’annuncio della relazione e invita a convocare la Commissione con maggiore continuità. Oscar Mina, presidente, condivide la necessità ma segnala difficoltà logistiche per la disponibilità delle sale. Carlotta Andruccioli (Domani Motus Liberi) insiste sull’importanza di affrontare con più frequenza i temi legati alla scuola e apprezza l’impegno sulla trasparenza del percorso europeo. Emanuele Santi (Rete) critica duramente il Governo per la lentezza nell’attuazione dell’accordo, lamenta assenza di comunicazione ai cittadini e sollecita la discussione urgente delle leggi ferme in Commissione. Marco Mularoni (PDCS) difende il lavoro svolto finora spiegando che i ritardi dipendono anche dalle tempistiche dell’Unione Europea e indica nella pubblica amministrazione il vero banco di prova dell’accordo. Giulia Muratori (Libera) conferma la necessità di recuperare ritardi sulla preparazione del Paese e propone strumenti di supporto per cittadini e imprese.
Al comma numero 2, inizia l’esame in sede referente del progetto di legge “Indicatore della Condizione Economica per l’Equità – ICEE”. Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi spiega che il progetto oggi in discussione approda in Commissione come progetto di legge e non come decreto da ratificare, perché la Segreteria ha scelto di privilegiare un percorso basato sul confronto politico. Belluzzi ricorda che la fase di sperimentazione dell’applicativo è già avanzata e che, grazie alla collaborazione con l’Associazione Bancaria Sammarinese, è stato risolto il tema dell’integrazione dei dati bancari nazionali all’interno del sistema digitale, rendendolo pronto all’operatività. Il Segretario entra poi nel merito degli emendamenti. Annuncia che alcuni degli emendamenti che ha presentato personalmente sono di natura formale, mentre altri introducono novità sostanziali tramite gli articoli 16-bis e 16-ter. Il cuore della riforma riguarda infatti l’introduzione dell’ICEE come strumento di valutazione della capacità economica, ma con una fase iniziale di sperimentazione. L’indicatore produrrà un dato numerico, ma non avrà effetti vincolanti immediati: verrà utilizzato per raccogliere informazioni, testare la tenuta del sistema e correggere eventuali criticità. Durante questa fase verranno coinvolti soggetti istituzionali e sociali per definire con precisione le fasce di accesso e le soglie delle future prestazioni collegate all’ICEE. Belluzzi sottolinea che sarà necessario armonizzare in particolare i dati immobiliari, distinguendo tra patrimoni detenuti in Repubblica e all’estero, perché l’assenza di un Catasto omogeneo oggi impedisce di definire correttamente il rapporto tra reddito e patrimonio.
Emanuele Santi (Rete) definisce l’ICEE uno strumento atteso ma insufficiente: denuncia tempismo inopportuno rispetto alla riforma IGR, eccessivo rinvio a regolamenti, rischio di elusione su redditi e patrimoni (trust, società immobiliari, beni all’estero), precompilazione dei dati disponibili alla PA e correttivi sulle distorsioni sociali e familiari. Carlotta Andruccioli (Domani Motus Liberi) accoglie positivamente il fatto che l’ICEE arrivi finalmente in aula come legge e non come decreto. Tuttavia critica la struttura del testo, ritenendolo troppo “vuoto” perché gran parte dei contenuti viene rinviata a regolamenti del Congresso. A suo avviso, parametri come soglie, scale di equivalenza o criteri per il calcolo dell’indice avrebbero dovuto essere fissati direttamente nella legge o almeno in allegati. Maria Katia Savoretti (Repubblica Futura), pur confermando il sostegno di principio alla misura, insiste sugli stessi timori: il testo arrivato in Commissione è molto diverso da quello presentato in prima lettura e rischia di diventare un guscio privo di contenuto se tutto viene demandato ai regolamenti del Congresso. Solleva preoccupazioni su privacy, sperimentazione e coordinamento con altri ambiti. Sul fronte della maggioranza, Marco Mularoni (PDCS) respinge l’accusa che il provvedimento sia “vuoto” e ricorda che l’ICEE è il frutto di un percorso lungo diverse legislature. Invita a non pretendere la perfezione da uno strumento che nasce in forma sperimentale e che dovrà essere aggiustato nel tempo. Difende inoltre l’uso dei regolamenti, che giudica più flessibili rispetto ai decreti delegati in caso di modifiche frequenti. Segue Giuseppe Maria Morganti (Libera), che sottolinea l’importanza dell’ICEE come svolta verso una vera equità sociale, superando l’erogazione “a pioggia” dei contributi. Ricorda che la legge prevede sanzioni pesanti per chi dichiara il falso per ottenere benefici indebiti. Enrico Carattoni (Repubblica Futura) porta l’attenzione sul tema più politico: il successo dell’ICEE dipenderà dalla chiarezza del perimetro della sperimentazione e dall’impatto che avrà su servizi come sanità e sociosanitario. Critica con forza la scelta di demandare al Congresso la definizione di elementi dal forte valore politico, come la classificazione dei beni di lusso. Sul tema della presunta “incertezza” dei redditi, Gemma Cesarini (Libera) puntualizza che la normativa fiscale sammarinese già prevede l’obbligo di dichiarare i redditi ovunque prodotti, compresi quelli derivanti da trust. Ammette comunque che lo strumento del trust può prestarsi ad abusi e per questo ritiene necessario potenziare i controlli da parte degli uffici competenti, non eliminare a priori tali casi dalla valutazione.
Terminato il dibattito generale, prima di procedere con l’esame dell’articolato, il Segretario di Stato Andrea Belluzzi chiede di sospendere i lavori per consentire un approfondimento sui vari emendamenti presentati. La seduta viene dunque interrotta. Riprenderà alle 14.30.
Di seguito una sintesi degli interventi:
- Comunicazioni
Segretario di Stato Andrea Belluzzi: In settimana procederò al deposito della relazione relativa all’accordo di associazione. In questo senso desidero ricordare all’aula che è stata preoccupazione, nell’ambito dell’assunzione del mandato alla Segreteria degli Interni, come prima cosa, di iniziare a studiare l’impatto dell’accordo e partire dal tema della formazione della pubblica amministrazione relativa all’accordo di associazione. È ovvio che, in questo senso, non è che si può partire senza prima aver fatto degli studi. Lo abbiamo fatto. Abbiamo anche iniziato dal confronto con i direttori di Dipartimento, con i dirigenti, anche perché nel frattempo c’è stato un cambio di direzione al vertice della Direzione della Funzione Pubblica. In particolare, con il nuovo dirigente, questo processo ha subito un’accelerazione su quello che riguarda il tema del confronto. Sarà un tema su cui occorrerà un impegno, un investimento da parte del Paese, proprio perché, in ambito dell’applicazione dell’accordo, un’amministrazione formata potrà essere il primo elemento di propulsione nello sviluppare l’accordo stesso. Sarà importantissimo creare un punto di riferimento per tutta la pubblica amministrazione, la cittadinanza, relativo all’informazione sulle potenzialità dell’accordo. Lo prevede già la legge Sviluppo. Avere una funzione, uno sportello, un luogo in cui chiunque, in particolare i giovani, possano avere le informazioni necessarie per implementare la propria capacità e le proprie potenzialità di essere cittadini dell’Unione Europea. C’è poi il tema della formazione, di un programma mirato per le varie fasce che ha la nostra amministrazione: dai dirigenti apicali, dirigenti delle singole UO, agli esperti che ci sono, proprio perché gradualmente dovremmo tutti prepararci in questo senso. È ovvio che non è un processo che si affronta in cinque minuti: dovrà essere un percorso che duri negli anni, strutturato. In questo senso credo che il ruolo e la collaborazione, anche da parte dell’Università di San Marino che ha già iniziato con alcuni master e comunque processi e percorsi di approfondimento, sarà importante. In questo senso chiudo dicendo che questo è uno dei dossier più importanti che ho ereditato e siamo partiti dall’inizio della legislatura nell’affrontare questo tema. Nell’ambito, ad esempio, dell’istruzione, noi avevamo già fatto un decreto in cui abbiamo affrontato il tema del riconoscimento dei titoli e delle qualifiche, che è uno dei passaggi importanti per, appunto, veder riconosciuto in San Marino questo aspetto. Un’altra cosa che avevamo fatto riguardava l’Erasmus: l’accordo con l’agenzia INDIRE per iniziare a prepararci, a strutturare la partecipazione degli studenti sammarinesi in quanto tali ma anche come studenti dell’Università della Repubblica di San Marino. E non solo, perché Erasmus Plus riguarda anche gli studenti liceali. E far sì che si cominciasse a lavorare, a creare le condizioni e gli strumenti, perché partecipare a Erasmus in questo senso non significa solo fare un accordo e si è operativi: magari fosse così facile. Purtroppo bisogna creare tutte le condizioni amministrative prima, e credo che i primi progetti possano partire proprio nel 2025.
Maria Katia Savoretti (RF): Ringrazio il Segretario per averci dato conferma che in settimana depositerà la relazione sull’accordo di associazione. Per noi è molto importante. Il nostro Paese, con l’accordo di associazione, farà una svolta importante ed epocale e noi dobbiamo essere pronti. E questa relazione che sarà depositata in settimana sicuramente è un punto fermo, un punto fermo da cui poi si deve riprendere in mano il tutto per vedere cosa manca e cosa dobbiamo fare come Paese per affrontare tutto quello che ci aspetta, sia nell’ambito della PA, ma non solo. Io ringrazio anche il Presidente per aver convocato questa Commissione. È passato diverso tempo, diversi mesi dall’ultima volta che ci siamo visti. Ritengo che questa Commissione debba essere convocata un pochino più spesso. Ci sono ancora dei PDL fermi lì, alcuni dei quali depositati da Repubblica Futura, che non hanno ancora visto un prosieguo. So bene le difficoltà che ci sono per trovare delle date libere perché questa sala è sempre impegnata e quindi dobbiamo rincorrerla tutte le volte. Però faccio presente che, dal 26 maggio, l’ultima volta che ci siamo visti, sono trascorsi troppi mesi e non dovrebbe succedere, perché ci sono tanti temi. Auspico che in futuro non si faccia passare troppo tempo tra una convocazione e l’altra, perché i temi comunque sono importanti e spesso sono attuali, e quindi penso che sia importante poterli affrontare in questa sede.
Presidente della Commissione Oscar Mina: Grazie, commissario Savoretti. Sì, lei ha ragione. Io concordo sulla sua valutazione sulle convocazioni. Purtroppo — anche per impegni della sala, soprattutto, ma anche per la disponibilità che a volte non ho da parte dei Segretari — ho difficoltà anch’io a organizzarmi per queste convocazioni. Però io sarei per farne una al mese. Se avessi una sede opportuna, più dedicata, potrei farlo più spesso.
Carlotta Andruccioli (D-ML): Bene come detto dal commissario Savoretti che ci siamo riuniti dopo tanto tempo. Ci sono tanti temi da affrontare. Io penso alla scuola in primo luogo, perché forse è il tema centrale di questa Commissione, tra il reclutamento, i temi organizzativi, la chiusura dei plessi, penso che quest’estate sia successo di tutto e sarebbe stato opportuno incontrarci anche preventivamente, non solo come conseguenza di decisioni magari già prese o di incontri che sono stati fatti in quel contesto. Comunque, ad ogni modo, faccio mio l’appello della collega di riunirci con maggior frequenza, ovviamente sulla base della disponibilità della sala, che è un tema, devo dire, annoso e che conosciamo molto bene. Su quanto relazionato dal Segretario Belluzzi, lo ringrazio e rimaniamo in attesa della relazione. Io penso che quello che il Segretario ha detto è sacrosanto: è un qualcosa che anche io, e anche noi come gruppo, diciamo da tempo, cioè l’importanza di informare la cittadinanza, quindi trovare i modi e gli strumenti per farlo, e l’importanza di approfondire e studiare quello che è l’impatto e l’applicazione dell’accordo. Io penso che quelle parole siano sacrosante, sono state dette soprattutto da molto prima. Quindi io non penso che si è ostili all’Unione Europea se si dice “approfondiamo, studiamo come si applica e soprattutto informiamo la cittadinanza”. Penso sia una cosa di buon senso. Quindi ben venga che ci sia questo tipo di relazione, che appunto aspettiamo.
Emanuele Santi (Rete): Noi abbiamo di fatto concluso il negoziato per l’associazione all’Unione Europea a dicembre 2023. Sono passati due anni. Io penso che a livello di Governo sia ormai imbarazzante l’inoperosità che state portando avanti su questo accordo. Non si è fatto nulla in due anni. Nulla. Si sta solo aspettando la firma che, fra l’altro, noi tutti speravamo che il vicepresidente Šefčovič venisse qua durante l’orazione a dire la data precisa in cui si firmerà. Purtroppo la data precisa non c’è: c’è solo un impegno a firmare “a breve”. Noi siamo veramente preoccupati. Quali sono i nodi che non sono stati sciolti e che ancora non permettono di arrivare alla firma dell’accordo? Sono passati due anni: ancora non è stato fatto né il sito né la comunicazione ai cittadini. Adesso io sono contento che questa settimana arrivi la relazione sulla PA, però noi abbiamo fatto l’audizione non più tardi di una settimana fa con l’onorevole De Luca e siamo rimasti molto preoccupati. Noi ci siamo spesi in tempi non sospetti, abbiamo detto che siamo disponibili anche a metterci a fianco delle forze di maggioranza perché questo accordo può essere una risorsa per tutti, a far comunicazione. Dopo l’abbiamo fatta per conto nostro, però non si sta facendo nulla rispetto alle esigenze che dovrebbe comportare la ratifica di questo accordo, anche rispetto agli impatti e ai tanti dubbi che i cittadini ci sollevano. Questo lavoro non si sta facendo. Quindi io dico: sono molto preoccupato. Rimarco il colpevole ritardo nel portare avanti tutte le questioni riferite all’accordo, soprattutto di comunicazione, ma anche rispetto agli impatti sulla pubblica amministrazione. Quanto alla convocazione della Commissione, mi piacerebbe che oggi ci prendessimo un impegno, e questo lo dovrebbero fare tutti i Presidenti delle Commissioni, non solo il Presidente Mina. Ci sono dei progetti di legge passati in prima lettura in Consiglio che devono arrivare in Commissione. E i progetti di legge non possono fermarsi alla prima lettura in Consiglio: bisogna che vengano in Commissione, che l’aula si esprima, anche per un “no”, se non vanno bene. Se le proposte dell’opposizione non vanno bene bisogna dire “no” e si bocciano. Quindi, a mio avviso, l’impegno importante che dovremmo prenderci oggi è — per quello che riguarda questa Commissione — di discutere al più breve tempo possibile la legge sulla cittadinanza e la naturalizzazione, che ormai è stata presentata il 3 di gennaio, fra l’altro è stata presentata dal Governo. Sono passati dieci mesi. Non è un tema semplice, ma non si può rimandare o lasciare nel cassetto. L’altra questione, a mio avviso, è il progetto di legge che avevano presentato i colleghi di Repubblica Futura, che riguarda il direttore di Dipartimento e il doppio ruolo della politica rispetto al caso del Segretario particolare della Segreteria Industria. Ognuno poi la pensa come vuole, però non possiamo tenere nel cassetto un progetto di legge perché non se ne vuole discutere. Si viene in aula, si discute, e poi si boccia se non siete d’accordo.
Marco Mularoni (PDCS): Parto subito proprio da questo punto: è volontà di tutti riuscire a riunirsi in Commissione perché ci sono vari progetti di legge che vanno esaminati. Il problema principale, oltre a far coincidere le date con le disponibilità dei Segretari e dei membri, è la sala. Dovremmo iniziare a ragionare su qualcosa di diverso, perché questa sala viene utilizzata per tutte le udienze, le festività, il Consiglio Grande e Generale, tutte le Commissioni, il Consiglio Giudiziario, praticamente quasi tutti gli organi dello Stato. Mi collego a quanto detto dal Commissario Santi sulla questione Europa. Bisogna scindere le varie questioni: bisogna capire se le dichiarazioni di “governo inoperoso” si intendano per la mancanza, oggi, di una data della firma, oppure se si intendano per l’operatività della questione. Il negoziato è stato chiuso a dicembre del 2023. Ad oggi non siamo ancora giunti alla firma, ma credo che il Segretario di Stato agli Affari Esteri abbia fatto comprendere quali fossero le motivazioni per cui oggi non abbiamo ancora firmato. Per la Repubblica di San Marino l’accordo rappresenta una priorità, ma dall’altra parte abbiamo un accordo internazionale con tre soggetti: San Marino, Andorra e l’Unione Europea. L’Unione Europea non è un singolo Stato, ma l’insieme di 27 Paesi. Nel Consiglio dei Ministri sono venute fuori diverse questioni: dalla competenza mista alla competenza esclusiva, dalla questione del memorandum e soprattutto — nella fase iniziale — dalla scrittura effettiva dell’accordo. Il negoziato è stato chiuso, quindi sono state decise le linee, i punti, gli allegati, le norme transitorie e le deroghe, ma tutto questo doveva essere scritto in termini giuridici e legali. È ovvio che un accordo di tale valenza abbia delle tempistiche che — magari nel nostro piccolo — non sono comprensibili, ma sono legate al fatto che stiamo contrattando con una macroarea che è l’Unione Europea, formata da 27 Paesi. L’altra questione è tutta la parte di adeguamento. Il negoziato con l’Unione Europea, fino alla chiusura del 2023, è stato portato avanti soprattutto dal Dipartimento Esteri e dalla Segreteria agli Esteri, interessando i vari soggetti che di volta in volta dovevano portare avanti le parti del negoziato, quindi anche la pubblica amministrazione. Oggi, invece, l’accordo — nel momento in cui verrà firmato — investirà tutti. Ed è per quello che il Segretario di Stato agli Affari Interni dice che, nel momento in cui ha assunto il mandato, si è subito adoperato: perché se fino alla parte del negoziato era una questione settoriale, oggi l’accordo deve investire tutti. La grande sfida di questo accordo sarà proprio la pubblica amministrazione: come riusciremo ad adottare tutte le normative europee, non solo quelle che oggi esistono ma anche tutto ciò che sarà la normativa europea futura. Dovremo essere capaci di guardare oltre, non semplicemente al regolamento che uscirà fra due mesi o entrerà in vigore fra tre mesi, ma a tutti i regolamenti dei prossimi anni. Credo che tutti i soggetti coinvolti in prima persona in questo sappiano effettivamente che la grande sfida è questa: preparare un Paese a qualcosa che fino ad oggi non si è mai visto.
Giulia Muratori (Libera): Mi unisco anch’io ad alcune riflessioni emerse questa mattina in aula. Partirei dall’accordo di associazione. È vero: ancora oggi non c’è una data, e però condivido quanto detto dal collega Mularoni. Non è un percorso in cui San Marino è l’unica parte partecipe: c’è anche l’Unione Europea dall’altra parte, con le sue tempistiche. Questo non va assolutamente in secondo piano. Ciò non significa che da parte nostra non ci sia la volontà o l’impegno a cercare di arrivare a una conclusione il prima possibile, e ci si sta impegnando in tal senso: la Segreteria agli Esteri sta lavorando in tal senso. Però questo non significa che non sia necessario evidenziare un ritardo nel preparare non solo il Paese, ma anche la pubblica amministrazione ad affrontare quello che sarà il recepimento dell’accordo di associazione, quindi del relativo acquis communautaire. Dobbiamo metterci subito al lavoro per recuperare il tempo che si è perso, perché dal momento in cui firmeremo e l’accordo entrerà in vigore, ci ritroveremo con la difficoltà di dover recepire tutta la mole di normative che arriveranno dall’Unione Europea. Ci sono risorse che hanno una conoscenza importante e che vanno in pensione: vanno affiancate in questo ultimo periodo per portare avanti il lavoro fatto fino ad adesso. E soprattutto c’è una grossa carenza di esperti nella pubblica amministrazione, visti anche gli ultimi bandi di concorso. Sono tutte riflessioni che dovremmo fare. Dovremmo trovare il modo per investire in certi tipi di risorse all’interno della pubblica amministrazione, che in questo caso ci aiuteranno a recepire l’acquis communautaire. Ma oltre alla pubblica amministrazione, dovremmo preparare il Paese. Mi riferisco alla necessità di preparare le imprese, le piccole attività, ma anche i cittadini, e tutte le occasioni formative che possono nascere dall’accordo stesso. Motivo per cui avevamo proposto la necessità di creare uno sportello che potesse avvicinarsi di più alla cittadinanza per capire insieme le opportunità da cogliere. Può essere uno sportello al Dipartimento Affari Esteri, o altrove. Ultima riflessione sulla legge sulla cittadinanza. È passato un po’ di tempo, è vero. Ci stiamo lavorando per portarla il prima possibile in Commissione. Sappiamo che è un tema divisivo, quindi vedremo quali saranno le posizioni dei vari partiti. È un tema delicato che va affrontato con le dovute cautele, riflettendo e trovando una sintesi il più possibile proficua per la legge stessa, facendo in modo che non si creino lacune o discriminazioni. Da parte nostra ci sarà l’impegno per darle la spinta giusta.
Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Sulle altre considerazioni che ho sentito, soprattutto sulla necessità della Commissione 1 di poter lavorare in maniera organizzata, è un tema importante e delicato che riguarda forse anche la Commissione per le Riforme Istituzionali. Oggi spesso è difficile trovare la sala disponibile per far lavorare le commissioni. Abbiamo la necessità di far lavorare contemporaneamente anche più commissioni. Poi c’è un problema di commissari con più incarichi. È una cosa positiva, però nello stesso tempo c’è la necessità, per la politica, di far lavorare contemporaneamente le commissioni per migliorare la produttività. Il tema del regolamento consiliare, ma anche del percorso e del processo riguarda il fare considerazioni sui processi con cui un progetto di legge entra in Consiglio Grande e Generale in prima lettura, e poi fa tutto il suo percorso per arrivare all’approvazione o alla bocciatura. Oggi sono processi un po’ macchinosi: spesso impattano non solo sui problemi del confronto politico, ma anche su problemi più contingenti che sono la disponibilità delle sale, il ruolo dei commissari. Abbiamo detto che vogliamo riportare al centro il ruolo del Consiglio Grande e Generale rispetto ai decreti. Allora, se diamo più carico di lavoro al Consiglio Grande e Generale attraverso le sue Commissioni, forse è opportuno rivedere il percorso con cui una legge fa il suo viaggio in Consiglio Grande e Generale, senza ledere la possibilità di confronto democratico fra maggioranza e opposizione, ma per avere un po’ più di efficienza e garantire una maggiore produttività. Queste problematiche, con le attuali regole del gioco, stanno mettendo sabbia negli ingranaggi e rendendo difficile percorsi veloci per progetti di legge della maggioranza e anche dell’opposizione, che oggi ha richiesto e denunciato la necessità di trattare in Commissione anche i loro progetti. Quindi i problemi sono comuni e la modifica delle regole del gioco è un argomento comune.
- Esame in sede referente del progetto di legge “Indicatore della Condizione Economica per l’Equità – ICEE” (presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni)
Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Non voglio stare qui a ripetermi sul valore del progetto. Vorrei concentrare il mio intervento su altri aspetti. Il primo è di natura politica. Siamo qui a discutere un PDL proprio perché, all’inizio della legislatura, eravamo pieni di decreti da ratificare. La scelta di questa Segreteria è stata di cambiare il percorso: anziché portare in ratifica un decreto, con le difficoltà di confronto che ha la ratifica di un decreto, trasformarlo in un PDL. Come avete potuto vedere, era sostanzialmente la trasposizione del decreto iniziale in progetto di legge, per avviare un percorso di confronto, portarlo in aula e arrivare finalmente in questa sede oggi, per confrontarci, vedere se è possibile trovare delle sintesi. Ci siamo già confrontati e avete potuto vedere come funziona l’applicativo. Abbiamo condiviso e trasmesso a Ciscoop alcune problematiche. Posso confermare e annunciare che è stato affrontato il tema di fornire all’applicativo i dati bancari sammarinesi. Ringrazio l’Associazione Bancaria Sammarinese che si è messa al tavolo e si è resa disponibile a trovare la soluzione tecnica. Abbiamo fatto passi avanti e siamo pronti alla sua entrata in vigore e al funzionamento dell’applicativo. Sugli emendamenti: ho bisogno di approfondire e guardare bene quelli presentati dall’opposizione. Ci sono alcuni temi su cui dobbiamo confrontarci e scioglierli. Primo fra tutti: l’opposizione propone, anziché il regolamento, il decreto come strumento per adeguare le tabelle e garantire elasticità allo strumento. Su questo è opportuno attivare il confronto in Commissione. Faccio una considerazione generale: è vero, il decreto ha un elemento positivo, cioè il confronto, perché si viene in aula e ci si confronta prima della ratifica. Il regolamento non ha questo aspetto. Non è il confronto il problema, il tema è l’elasticità, quello che ho detto nel mio intervento precedente: evitare di sovraccaricare il lavoro consiliare di decreti. L’ideale sarebbe avere un regolamento senza privarlo del confronto politico. Spesso il Consiglio si trova incastrato nel poter affrontare i decreti tempo per tempo. Vengo agli emendamenti presentati da me. Alcuni sono meramente correzioni formali. Valuteremo insieme se metterle in votazione o se possono essere trattate come tali. Altri, soprattutto gli articoli 16-bis e 16-ter, introducono novità rispetto all’impianto del provvedimento che nasce come decreto e introducono l’apertura di una fase transitoria di studio. Rendere obbligatoria la compilazione dell’ICEE come strumento necessario per accedere ad alcune provvidenze, ma senza rendere l’ICEE subito applicativo. L’applicativo ICEE esprime un numero, un dato indicativo della capacità economica del dichiarante e del nucleo familiare. Avere una fase sperimentale, con un tavolo che coinvolge soggetti con ruolo sociale e istituzionale, serve per apportare modifiche e rettifiche dopo un periodo di utilizzo, quando i dati raccolti avranno una base statistica. Così le riforme che si dovranno agganciare potranno basarsi su numeri precisi per definire le fasce di accesso e le soglie. La fase di sperimentazione e acquisizione dati è fondamentale prima che l’ICEE produca un effetto vero e proprio. Dovremo anche adeguare e armonizzare i dati immobiliari tra immobili detenuti in Repubblica e all’estero. La fase sperimentale permetterà di armonizzare questi valori nel tempo, così che lo strumento, una volta entrato in vigore, sia efficace ma anche equo, esprimendo un dato effettivamente indicativo e non generando sperequazioni o disuguaglianze. Nessuno vuole questo. Deve essere uno strumento che, ai sensi della nostra Carta dei Diritti, garantisca la gradualità di accesso in base alla propria capacità reddituale e alla propria condizione economica. Vedo che tutti gli emendamenti vanno a ritoccare anche il rapporto patrimonio/reddito. Anche io l’ho corretto rispetto alla versione depositata in prima lettura, frutto di confronto con le parti sociali e come strumento per riequilibrare il fatto che, finché non si arriva a una riforma del Catasto, il rapporto tra patrimonio e reddito non è preciso, perché non abbiamo dati armonizzabili tra patrimoni detenuti in Repubblica e patrimoni detenuti all’estero. Quello deve essere uno dei lavori principali su cui si deve concentrare la fase di sperimentazione.
Emanuele Santi (Rete): Siamo arrivati alla discussione di uno dei progetti di legge più importanti di questa legislatura. Un progetto di legge che è sul tavolo da ormai cinque o sei anni. È lo strumento ICEE, che va a calmierare e destinare le risorse dello Stato verso chi ha più bisogno. Chi ha più bisogno deve avere di più, chi ha meno bisogno deve avere di meno. In questo periodo storico la coperta è corta e le risorse dello Stato devono essere allocate in modo corretto. Noi lavoriamo su questo testo da diversi anni e abbiamo portato le nostre osservazioni in molti tavoli, non ultimo al Segretario di Stato Belluzzi: siamo andati nella sua Segreteria nell’agosto 2024 e avevamo già allora presentato alcune considerazioni, quando ancora era un decreto delegato. Il fatto che sia stato poi ripresentato come progetto di legge è certamente meritorio: uno strumento così importante è giusto che sia trattato come progetto di legge. Tuttavia, già allora avevamo sollevato alcune criticità che oggi illustrerò. A nostro avviso, questo strumento che oggi andiamo a introdurre nel sistema sammarinese è uno strumento vuoto, uno strumento miope, e il momento è inopportuno. Tra una decina di giorni dovremo definire la legge IGR, di cui non sappiamo ancora quale sarà il punto di caduta. Senza conoscere quel punto di caduta, il rischio è che con questo strumento si vada ulteriormente ad aggravare la posizione di chi pagherà il conto dell’IGR. Con l’impostazione data all’ICEE, si conferma il fatto che chi può nascondere o eludere potrebbe essere premiato. Questo è il grande deficit del progetto di legge. Lo strumento è miope perché crea un indice sulla base del reddito e del patrimonio che uno ha, ma sappiamo bene che se il reddito di alcune categorie è certo, per altre non lo è. Per chi ha la possibilità di nascondere redditi o patrimoni, non è previsto nulla. Non bastano alcune enunciazioni generiche quando si parla di trust: le cose bisogna scriverle bene. Con gli emendamenti abbiamo cercato di evidenziare i possibili strumenti elusivi. Ci sono categorie di reddito certo e categorie su cui abbiamo dubbi. Lo stesso vale per i patrimoni. Sentiamo dire che con l’ICEE emergeranno tutti i patrimoni: non è così. Se i beni vengono conferiti in un trust o in società immobiliari, questi patrimoni non emergeranno nell’ICEE. Se una persona fisica è proprietaria di una villa, quella villa entra nel calcolo ICEE. Ma se quella stessa villa è intestata a una società o a un trust, pur beneficiandone, non entrerà nel conteggio. Su questo abbiamo presentato un emendamento per eliminare l’effetto distorsivo. È un provvedimento vuoto anche perché rimanda a quindici regolamenti. I regolamenti li emette il Congresso. Su quali linee? Non ci sono linee. Qui manca una direzione. È una delega in bianco, peggio di una delega a fare un regolamento che nessuno vedrà. Gli emendamenti che abbiamo presentato vanno in parte a correggere questo: non ci piace la delega, ma se dobbiamo scegliere tra regolamento e decreto delegato, almeno con un decreto delegato abbiamo un passaggio consiliare e una discussione in aula. Se il provvedimento arriva in aula e rimanda a quindici ulteriori provvedimenti, significa che la struttura c’è ma manca la sostanza. La sostanza si poteva scrivere nella legge. Già ad agosto 2024 avevamo segnalato al Segretario alcune modifiche necessarie, perché un vero strumento di equità deve garantire che chi accede alle provvidenze sia realmente bisognoso, dimostrando la sua capacità reddituale e patrimoniale. Così com’è, non considerando alcuni parametri, il rischio è che questo provvedimento si presti a distorsioni. Ci sono situazioni — segnalate nel tempo — in cui persone abbienti ottengono benefici pur non avendone diritto, semplicemente perché riescono a nascondere l’entità reale dei propri patrimoni e redditi. Se non introduciamo strumenti per evitare queste distorsioni, a fine periodo di prova l’ICEE funzionerà benissimo per chi ha redditi certi — cioè per chi ha sempre pagato — ma andrà malissimo per chi ha la possibilità di nascondere. Le società immobiliari con decine di immobili, facenti capo a soggetti ben identificabili, oggi non emergono nell’ICEE. Se detengo proprietà all’estero o beni all’estero, bisogna stabilire che vadano dichiarati e rilevati nell’indice, altrimenti chi può eludere o evadere continuerà a beneficiare di prestazioni a cui non avrebbe diritto. Con i nostri emendamenti abbiamo cercato di intervenire, soprattutto nelle deleghe. Non pretendiamo di scrivere già i regolamenti, ma alcune cose vanno fissate. Ad esempio: il patrimonio viene oggi valutato solo al 20%. Noi proponiamo 50 patrimonio, 50 reddito. Se uno ha dieci milioni di euro e reddito zero, deve emergere: perché oggi può succedere che chi ha dieci milioni nascosti risulti povero e acceda a provvidenze. E vivere in un Paese dove questo accade è, oltre che scorretto, francamente antipatico. Altra questione: la compilazione dell’ICEE. Oggi si imposterebbe così: il cittadino deve autodichiarare. Ma ci sono dati che la Pubblica Amministrazione possiede già. Questi dati devono essere precompilati. Se uno ha tre mezzi, magari ha uno scooter dimenticato da anni in garage ma ancora intestato: deve emergere automaticamente. È una banalità, ma è così che si evitano errori o furberie. E poi la questione familiare. Parliamo anche di un tema sociale. Ci sono anziani che risultano soli, non accuditi dai figli: formalmente poveri, quindi beneficiari. Ma magari hanno figli milionari. Anche questo va detto: il diritto di famiglia implica che chi ha figli o familiari deve, nei limiti del possibile, farsene carico. In conclusione: bene che l’ICEE parta, male nei contenuti. È vuoto nei contenuti, è sbagliato nel metodo, perché rinvia tutto ai regolamenti senza fissare in legge i paletti essenziali. E soprattutto non affronta le distorsioni che ho evidenziato.
Carlotta Andruccioli (D-ML): Sottolineo anche io l’importanza di essere arrivati finalmente alla discussione di questo progetto di legge. In primo luogo perché, appunto, sono anni che se ne discute. Condividiamo l’importanza dello strumento, anche perché devo dire che è sempre stato negli anni un po’ l’alibi per non procedere con tantissime altre norme. Almeno verrà a mancare anche questo alibi. Prima il Segretario diceva che non è stato un decreto, ma si è voluto fare direttamente una legge. Io penso che, di per sé, sia ottimo, perché l’iter della legge permette di discuterne in maniera più approfondita e con le dovute tempistiche. Quindi questo è apprezzabile. Però spiace constatare che tantissime parti sostanziali del progetto di legge non siano presenti nella legge, ma siano rimandate a regolamenti del Congresso di Stato. Io mi sarei aspettata che ci fossero magari degli allegati alla presente legge e che quindi fin dal principio venissero riportati i parametri, le soglie o le disposizioni collegate. C’è l’esempio della scala di equivalenza, quindi i parametri corrispondenti al numero di componenti; c’è l’esempio dei parametri della condizione reddituale, della condizione patrimoniale e tantissimi altri aspetti per il calcolo dell’ICEE che non sono presenti già nella legge, ma vengono rinviati a regolamento. E quindi, di fatto, la legge è vuota. In molti emendamenti abbiamo proposto di sostituire il regolamento con decreto delegato. Avremmo preferito che molti aspetti fossero presenti già all’interno della norma. Tant’è che, in un caso specifico, quello della scala di equivalenza, abbiamo fatto una proposta forse anche un po’ provocatoria, inserendo direttamente i parametri nella legge, sulla base del modello italiano. Su temi come questi io penso che quel confronto in più, quell’approfondimento in più che l’Aula consiliare può dare possa rappresentare quel quid in più per portare un provvedimento più completo. Un altro emendamento che abbiamo proposto, e che poi avremo modo di approfondire, riguarda l’importanza che siano aggiornati i parametri e le soglie utilizzate per il calcolo dell’ICEE, proprio perché la legge deve essere mantenuta nel tempo sempre attuale. Quindi bisogna verificare che gli indicatori tengano conto delle modifiche intercorse negli anni sul piano dell’inflazione, del costo della vita, della variazione dei prezzi, eccetera. Ritengo importante che ci si prenda l’impegno di inserire comunque un obbligo di consultazione pubblica, o meglio di confronto con le parti sociali e con tutta la politica, quindi con i sindacati in primis. Io penso che — IGR docet — sia controproducente fare le cose con arroganza e senza un opportuno confronto. Quindi tutte le condivisioni possibili, secondo me, sono opportune: perché sì, è un provvedimento tecnico, ma ha un riflesso sulla vita di tutti. Quindi l’aspetto del coinvolgimento nell’elaborazione della normativa secondaria, secondo me, va ribadito. Non so se serve ribardirlo nella legge o se ci prendiamo un impegno qui, però è importante.
Maria Katia Savoretti (RF): Questo progetto di legge per noi è un progetto importante, è da tempo che lo aspettavamo in quest’Aula. La posizione nostra è sempre stata una posizione favorevole, perché — ripeto — era un progetto che abbiamo sempre richiesto e incentivato al Governo e alla maggioranza. Quindi nessuna contrarietà per quanto riguarda l’intervento. Ci sono però, entrando nel merito, alcune osservazioni che devo fare. Vedendo gli emendamenti, ci troviamo ancora una volta, e lo devo sottolineare, con un testo che è diverso da quello che invece è stato portato in prima lettura. Bisogna fare attenzione, altrimenti — come sta succedendo per l’IGR — in prima lettura portiamo un testo, poi rimane nel cassetto per tanto tempo e, quando viene presentato in Commissione, è un testo completamente nuovo rispetto a quello che abbiamo esaminato in prima lettura in quest’Aula. Esaminando il testo, alcune criticità ci sono. Noi, come forza politica, non abbiamo presentato emendamenti, però riteniamo sia corretto non rimandare tutto al regolamento del Congresso. Io capisco il Segretario; lui stesso ha detto che comprende, ovviamente, la nostra obiezione. Lui dice: “Lo si fa per accelerare l’iter”. Bene, accelerare l’iter, però non è questo il comportamento corretto, perché con il regolamento del Congresso, in quest’Aula — all’interno del Consiglio Grande e Generale — non passa nulla e decide tutto, in maniera unilaterale, il Congresso di Stato. E questo non è corretto, anche perché in questo testo di legge molte cose non ci sono e invece ci sarebbero dovute essere. Quindi tutto a discrezione del Congresso di Stato e, a nostro avviso, ciò assolutamente non è corretto. Il progetto di legge, a nostro avviso, tocca semplicemente alcune categorie di cittadini, o meglio il ceto medio, e non magari i lavoratori autonomi. Altra cosa: è stata introdotta la sperimentazione. Nel momento in cui si fa il periodo di prova e poi avete visto che la prova non ha portato a un esito positivo, cosa si fa? Alle categorie, ai cittadini ai quali non è stato concesso il servizio o il contributo, poi si torna indietro? Altra questione: privacy. Occorre ovviamente fare veramente tanta tanta attenzione quando si forniscono anche i dati. Quindi bisogna capire come effettivamente ci sia la tutela. Altra cosa: anche a nostro avviso c’è un divario tra reddito e patrimonio. Cioè non è sempre detto che chi ha un reddito un pochino più elevato poi abbia invece un patrimonio alto. Quindi secondo me bisognerebbe un attimino valutare meglio, perché questo binomio reddito-patrimonio non sempre dà quello strumento corretto che ti permette di intervenire. L’intervento che si fa con questo PDL come si andrà a uniformare con le leggi che regolano, ad esempio, il diritto allo studio? Poi, non solo: con l’ICEE e quindi con questi parametri andremo anche a decidere chi potrà accedere a certi servizi sanitari, ai servizi sociosanitari. E infine anche io mi associo a quello che ha detto chi mi ha preceduto: il fatto che ci debba essere una maggiore condivisione. Perché anche l’ICEE è un progetto di legge che avrà — una volta che entrerà in vigore — un impatto non indifferente. Però, ripeto, è importante, perché fino ad oggi abbiamo dato contributi senza guardare veramente a chi ne avesse bisogno. E non va bene. Però, dall’altra parte, dobbiamo stare attenti e fare valutazioni più approfondite per evitare di fare quegli errori che non devono essere fatti.
Marco Mularoni (PDCS): E’ stato definito un progetto di legge vuoto. Io sinceramente credo che non sia minimamente così, anzi: è nato questo provvedimento cinque-sei anni fa, quando c’era l’allora Segretario di Stato agli Interni Tonnini, che l’aveva portato avanti. Poi l’hanno ereditato il consigliere Berti e oggi il Segretario di Stato Belluzzi, dove gran parte del lavoro era già stato fatto. Quindi io non credo che questo intervento sia vuoto, anche perché noi fino ad oggi abbiamo conferito contributi a tutti, indistintamente dalla loro situazione. In realtà, oggi stiamo mettendo in pratica — come poi ha detto anche il Segretario Belluzzi — uno dei principi contenuti nella nostra Carta, e quindi credo che questa sia la prima osservazione da fare. Dobbiamo ricordare che questo è uno strumento in parte sperimentale. Il primo strumento che nasce non può essere perfetto. Io credo che sia impossibile creare uno strumento tale per cui si possa andare a prevedere tutte le situazioni o eventualità. Dovremmo vederle nella pratica: oggi ragioniamo solo in teoria, dovremmo effettivamente metterlo in pratica, vedere i dati, vedere cosa viene fuori. Altra questione è quella tra regolamenti e decreti. Io comprendo i commissari di opposizione che hanno fatto emendamenti volti a introdurre decreti delegati. Capisco che giustamente dicono che è giusto che il Consiglio Grande e Generale, in sede di ratifica, abbia la possibilità di visionare questi interventi, perché comunque sono regolamenti sì, tecnici e applicativi, ma hanno delle ripercussioni sullo strumento dell’ICEE. Quindi, in questo caso, consiglio di poter ragionare con strumenti differenti, o magari con una dichiarazione verbale in cui si prende l’impegno prima di emanare questi regolamenti. Da parte nostra c’è apertura, ma sono comunque fermamente convinto di lasciare i regolamenti e di non prevedere dei decreti. Se mettiamo decreti, vuol dire che per ogni minima virgola dovremmo ritornare in Consiglio Grande e Generale. Se nella riforma IGR vengono modificate determinate cose, vuol dire che dovremmo poi fare tanti emendamenti per andare a modificare i vari decreti. Quindi comprendete che è un qualcosa che andrebbe ad aggravare veramente l’iter legislativo. Partiamo dal presupposto che questo è uno strumento sperimentale. Noi stiamo parlando di teoria: non abbiamo ancora contezza effettiva della pratica di questo strumento, di quali saranno i suoi risvolti proprio sui cittadini. Quindi, io comprendo benissimo le opposizioni. Ma non sono d’accordo sul modificare prevedendo dei decreti, perché poi si avrebbero un sacco di problematiche ogni qualvolta avremo la necessità in futuro, sia questo governo che i futuri, di andare a modificare anche semplicemente una virgola o una lettera. Per quanto riguarda poi le osservazioni sul trust, c’è comunque un paragrafo che disciplina il trust. Ovviamente, giustamente, i commissari di opposizione segnalano tutta una serie di distorsioni di quelle che oggi sono. Però c’è sempre la possibilità in futuro di modificarle e anche di individuare tali distorsioni. È impossibile creare una normativa perfetta. Dobbiamo essere bravi tutti noi ad andare avanti su questo progetto di legge, perché fino ad oggi non esiste nessuno strumento di legge tale per cui si possano dare contributi riportando un tema di giustizia sociale, perché oggi verrebbero dati indistintamente a tutti. Quindi credo che partiamo da questo: guardiamo, osserviamo e, in base ai dati, successivamente avremo la possibilità di intervenire con più contezza e con più puntualità e determinazione.
Giuseppe Maria Morganti (Libera): Questo provvedimento finalmente arriva in aula, viene discusso e mi auguro che al più presto possa essere approvato. La finalità è evidente, quindi non sto a ribadirla: è uno strumento importantissimo per generare un concetto fondamentale che sta alla base della convivenza di tutte le società, quello dell’equità sociale, che prevede la possibilità di destinare risorse maggiori a chi ne ha più bisogno e minori, o addirittura di non destinarne, a chi non ne ha necessità. Questo è un discrimine fondamentale, perché fino ad oggi il nostro Stato ha elargito a pioggia risorse e disponibilità a tutti. Mi dispiace che ci siano critiche da parte dell’opposizione, che non sono del tutto giustificate, perché ci troviamo in una fase sperimentale, trattandosi di un intervento legislativo particolarmente complesso in una realtà quale quella sammarinese, dove la determinazione dei redditi delle persone e dei loro patrimoni è sempre stata problematica. Per fortuna ci sono state leggi che hanno introdotto nuovi criteri, soprattutto in ambito fiscale, a partire dagli anni ’80-’90. Prima non si parlava nemmeno di verificare i redditi delle persone nella Repubblica di San Marino. È chiaro che la definizione esatta di una necessità — non di un reddito specifico, ma di una necessità — è molto complessa, perché sono tantissimi i fattori che intervengono: reddito, disponibilità patrimoniali, condizione sociale, dimensione familiare e altri. Sono elementi che difficilmente un algoritmo può considerare e definire pienamente, quindi è giusto partire con una fase sperimentale. Oggi possiamo intervenire con una legge quasi “quadro”, che avrà bisogno di ulteriori interventi di aggiustamento, affinché sia sempre più precisamente finalizzata allo scopo espressamente citato nell’articolo 1. Molto spesso succede che interventi di assistenza o di aiuto messi in campo dallo Stato verso famiglie e cittadini finiscano nelle mani di chi non ne ha bisogno. Uno per tutti: il famoso assegno di studio, che ha criticità; in alcuni casi anche gli assegni complementari di sostegno a chi ha redditi pro capite bassi. Fatta questa premessa, e considerando la disponibilità dell’aula a ragionare sugli obiettivi e le finalità del provvedimento, credo che in questa Commissione possiamo fare un buon lavoro, tenendo presenti i punti di vista espressi. Uno fra tutti: è giusto che ogni intervento su questa materia possa essere analizzato e valutato dal Consiglio Grande e Generale o da un organo come questa Commissione, affinché le forze politiche possano intervenire e capire gli aggiustamenti proposti di volta in volta attraverso i regolamenti del Congresso di Stato. Il provvedimento richiama l’articolo 297 del Codice Penale. Se lo Stato si accorge che qualcuno ha dichiarato molto meno di quanto dovuto o vuole approfittare dell’ICEE per ottenere maggiori sussistenze, l’articolo 297 interviene e porta non solo alla restituzione delle somme, ma a penalità molto pesanti, con una deterrenza notevole rispetto a un guadagno effimero che qualcuno pretende di ottenere agendo nelle maglie della normativa. È chiaro che un provvedimento legislativo non può prevedere il 100% dei casi, e probabilmente qualcosa sfuggirà sempre. Ho partecipato ad alcuni incontri con le organizzazioni sindacali, che avevano qualche perplessità. Oggettivamente non ne capisco le motivazioni: è vero che chi non ne ha bisogno non potrà più godere — o godrà in misura minore — degli interventi dello Stato; ma questo è un elemento di giustizia sociale fondamentale. Chi ha bisogno godrà di interventi maggiori: è un elemento di equità da sottolineare.
Enrico Carattoni (RF): Il sentimento unanime da parte di quest’aula è quello di arrivare in maniera veloce alla definizione di un testo che possa individuare quella che è la reale “ricchezza” di ogni contribuente, in modo da permettere poi di tarare i servizi che eroga lo Stato. Questo dato si interseca però con un primo elemento: in tutti questi anni ci siamo sempre detti che si voleva tarare determinati benefici in considerazione delle fasce di reddito, che è il primo parametro certamente più indicativo. Ma si diceva: quello sarebbe un parametro imperfetto, perché sappiamo che a San Marino l’accertamento del reddito è un tema complesso e quindi più che andare verso l’equità si rischierebbe di allontanarsene ancora di più. E allora da qui l’ICEE, che ricalca un parametro che in Italia esiste da più di vent’anni, l’ISEE. A San Marino però questo progetto di legge ha avuto un iter travagliato. Il primo ideatore è stato il governo Adesso.sm con il segretario Guerrino Zanotti che già nel 2017-2018 aveva abbozzato un testo abbastanza completo rispetto a questo parametro. Poi si è succeduto un altro governo con altri due segretari di Stato, e addirittura Berti, l’allora segretario, ci disse che il testo era già pronto in dirittura d’arrivo prima delle elezioni del 2024, quindi già nel 2023-2024. Poi siamo dovuti arrivare a fine 2025 per entrare nel vivo di questo progetto di legge e per vedere, valutare, quello che sarà l’impatto concreto. In linea di principio questo è uno strumento che permetterà di togliere quelle sacche di iniquità che purtroppo ancora oggi ci sono. Saranno riflessioni a volte demagogiche, però è chiaro che l’asilo nido, la scuola dell’infanzia o altri servizi vengano pagati in maniera uguale da un nucleo familiare che ha un figlio o da un nucleo che ne ha sei, non è giusto. Detto questo, però, delle riserve ci sono. In primo luogo bisognerà capire in che cosa consiste, segretario, questa fase di sperimentazione che si legge fra le righe degli ultimi articoli del progetto di legge. Perché è chiaro che quello che viene fatto oggi è un grande filtro: è uno strumento che poi permetterà di essere applicato a determinate categorie di servizi da erogare, che però ancora oggi non è chiaro quali siano. E questo è un quesito che pongo al governo: verrà applicato anche all’erogazione di servizi sanitari o sociosanitari, superando il concetto di gratuità e universalità delle prestazioni sanitarie? Questo credo sia un tema da chiarire: se alla fine della fase di sperimentazione ci sarà questo passaggio oppure no. E poi, secondariamente — e questa è un’innovazione che accolgo con enorme sfavore — è una tecnica legislativa che permette di delegare al Congresso di Stato, ma non più sotto forma di decreto delegato, l’individuazione di tante tipologie: per esempio l’individuazione dei beni di lusso. A me pare che in questa legislatura si sia scoperto questo strumento del regolamento del Congresso di Stato, che diventa un po’ il rifugio peccatorum. Perché definire che cosa è o non è un bene di lusso — soprattutto che cosa non è — è un tema politico sul quale, per esempio, molti di noi potrebbero voler avere voce in capitolo. Quindi credo che questo scavalcamento del Consiglio Grande e Generale in favore del governo non possa trovare condivisione, specialmente su un tema nel quale si poteva trovare un consenso ampio e largo. Tutte le forze politiche rappresentate oggi in aula, a vario titolo, hanno avuto responsabilità di governo e tutte quante hanno sostenuto — non solo nei programmi, ma anche nelle azioni concrete — passi avanti verso questo progetto di legge. Oggi farle scontrare attraverso tecnicismi che fanno sembrare che non ci sia una piena volontà di trovare condivisione, io credo che sia una macchia nera importante. Su un tema che, invece, poteva essere discusso in maniera unitaria e poteva essere il contraltare rispetto a una riforma IGR discussa e contestatissima, e che invece poteva trovare una condivisione non solo delle forze dell’aula ma anche delle forze sociali. Così non è, e di questo mi dispiaccio.
Gemma Cesarini (Libera): Anche io mi unisco ai colleghi quando si rileva con favore che è stato portato un progetto di legge invece che un decreto delegato, e quindi è chiaramente una nota positiva. Stiamo facendo un passo molto importante verso la direzione di misurare le provvidenze che vengono elargite ai cittadini. Il tema del decreto delegato e del regolamento è vero che si presta a discrezionalità, ma è vero anche che noi abbiamo i regolamenti, previsti dalle nostre leggi, che dovrebbero essere utilizzati per l’adozione di aspetti più tecnici che non si prestano a valutazioni in merito a criteri o principi. In questo senso mi riferisco, per esempio, all’adozione di una tabella o a una questione prettamente tecnica, mentre quando parliamo di criteri e principi forse dovremmo fare riferimento ai decreti delegati. Sul tema dell’incertezza dei redditi vorrei fare una precisazione. La legge fiscale, la legge IGR, prevede un principio che è quello della dichiarazione dei redditi ovunque prodotti, il cosiddetto worldwide principle. Non è corretto dire che c’è incertezza in questo senso: il beneficio percepito da un trust, ad esempio, deve essere dichiarato. Che il trust sia uno strumento che si presta ad opacità è altrettanto vero, e forse in questa fase sperimentale è proprio questo che ci serve capire. Partendo dal tema del trust, voglio fare due esempi. L’esempio buono è quando il trust viene costituito per gestire l’eredità in capo a un bambino, a un figlio, e in questo caso lo scopo è quello di proteggere da avventori terzi. Oppure abbiamo il caso completamente opposto del miliardario che costituisce un trust per nascondere le sue proprietà e percepire esclusivamente un beneficio che è magari un quarto del valore del patrimonio. Allora, se dobbiamo escludere aprioristicamente qualcosa solo perché c’è il rischio che ci sia il caso malato, forse non è il ragionamento giusto. È vero però che questo istituto si presta ad opacità, e quindi forse è il caso di potenziare gli strumenti di controllo che devono essere affidati agli uffici competenti. Detto questo, non vorrei andare troppo nel tecnico e dico solo che, proprio perché abbiamo parlato di fase sperimentale, è il caso di partire con alcuni casi concreti e vedere che cosa riusciamo a capire da questi casi.
Segretario di Stato Andrea Belluzzi, replica: Sono stati chiesti dei chiarimenti. La privacy, ad esempio: noi ci siamo avvalsi, nel redigere il progetto, del fatto che l’Autorità Garante della Privacy è per legge consulente del governo per il rispetto della normativa, e in questo senso noi il confronto lo abbiamo fatto. Gli articoli che riguardano la riservatezza delle informazioni sono stati tutti verificati con l’Autorità Garante, sia per quanto riguarda i dati interni che esterni. L’articolo 16 prevede una fase sperimentale nella quale diventa obbligatorio, per accedere alla provvidenza così come prevista dalle leggi vigenti, la semplice compilazione della dichiarazione ICEE. Questo non significa che, sulla base del contenuto della dichiarazione ICEE, si eroga la provvidenza: la provvidenza rimane, per il periodo di sperimentazione, erogata così come oggi. Però, per accedere alla provvidenza, occorre consegnare compilata la dichiarazione ICEE, per acquisire i dati e le informazioni. La verifica la farà l’osservatorio sulla corretta funzionalità dell’applicativo ICEE e della normativa, in previsione di future modifiche e in previsione della correttezza dei regolamenti che stiamo discutendo e sui quali si è sollevata la questione se debbano essere adottati con delibera del Congresso di Stato oppure con decreto. Io penso che, condividendo la necessità di condivisione e informazione preventiva della politica, e considerando che ogni forza politica rappresentata in consiglio ha un suo membro nell’osservatorio, potrebbe essere una soluzione valutare di modificare ulteriormente il 16-bis prevedendo un passaggio obbligatorio e un parere obbligatorio, anche se non vincolante, dell’osservatorio sulle proposte di regolamento o di decreto previste dall’articolato. Chiarito questo passaggio, che penso possa essere preso in considerazione per trovare una sintesi tra il diritto-dovere dell’opposizione di dare il proprio contributo e l’esigenza di evitare di arrivare in aula, prendo atto anche dell’indicazione di discernere tra aspetti più tecnici e meno tecnici per quanto riguarda decreti e regolamenti. Un’ultima cosa, andando a conclusione: questo progetto di legge ha avuto una continuità nel tempo. Se andiamo a guardare il decreto emesso originariamente e quello successivo, differiscono per pochissimo, non hanno differenze sostanziali. Uno degli aspetti riguarda l’aspetto regolamentativo. Ringrazio anche il commissario che, con riferimento al trust, ha precisato che il trust è trattato negli articoli 7 e 8 del progetto di legge. L’articolo 7 fa riferimento ai redditi e, laddove non parla di trust in maniera specifica, comunque definendo i redditi secondo l’IGR, incide per il dichiarante. L’articolo 8 menziona esplicitamente il trust, mi pare comma 5, e lo tratta laddove il trust conferisce un bene di cui è beneficiario un componente del nucleo familiare, proprio per evitare distorsioni o elusioni. È importante ricordare che il PDL tratta la creazione dell’ICEE, dell’indicatore. Questo non significa che i singoli provvedimenti agganciati, che tutti aspettiamo e auspichiamo, non possano essere riformati. Prendiamo ad esempio il diritto allo studio: verrà riformato e agganciato all’ICEE, ma il PDL di riforma del diritto allo studio potrà autonomamente escludere i beneficiari di trust dalla provvidenza, a prescindere dal contenuto dell’ICEE. Questo vale per altri progetti e riforme. L’ICEE dà una fotografia precisa, o più precisa possibile, e proprio per questo occorre il periodo di sperimentazione e occorrono deleghe e regolamenti, perché sia più precisa possibile e si evolva in base alle riforme IGR e all’informatizzazione dell’amministrazione, e alla capacità di scambio di informazioni coi paesi esteri, non solo l’Italia.