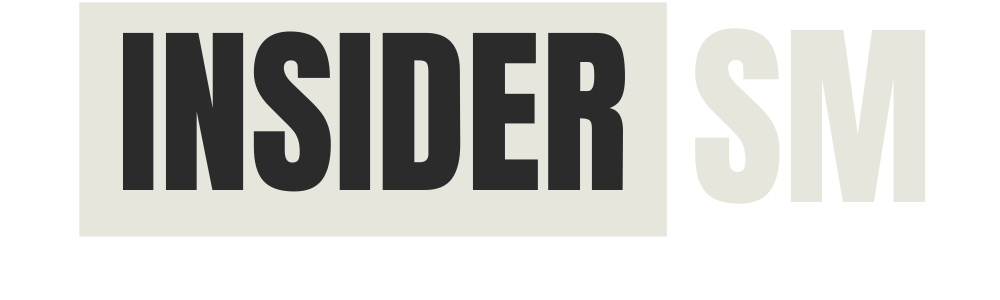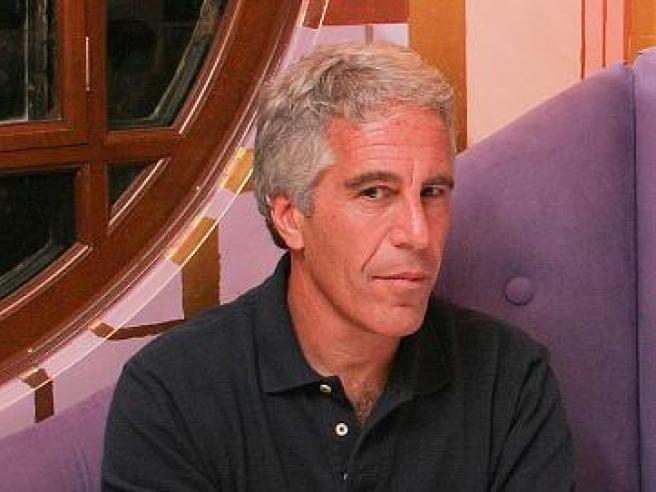I lavori della Commissione Consiliare per le riforme istituzionali ha al centro, nella giornata del 21 ottobre, una serie di audizioni.
Il primo a prendere la parola è Guido Guidi, professore universitario di Diritto Pubblico Comparato e di Diritto Amministrativo. Nel suo intervento, il prof. Guidi si sofferma sulla centralità storica del Consiglio Grande e Generale come fulcro dell’ordinamento sammarinese e, rispetto al dibattito europeo su premierato e presidenzialismi, ritiene che San Marino privilegi la stabilità alla “governabilità”, giudicando positive le riforme elettorali recenti e mettendo in guardia contro lo scioglimento automatico del Consiglio.Nel rapporto tradizione/innovazione, Guidi sostiene una sintesi: si conserva ciò che è “fuoco vivo” e si abbandona ciò che è inerte. La centralità del Consiglio implica la centralità dei partiti, ma propone di rafforzare le istituzioni accanto ai partiti: valorizzare la Reggenza come garante, riconsiderare il finanziamento spostandolo dai partiti ai gruppi consiliari, e avanzare -come provocazione – l’idea di legare più strettamente i vertici di partito al Congresso di Stato. Evidenzia gli elementi che attenuano la centralità e invita a non importare modelli dei grandi Stati (come quello del bicameralismo) in un contesto di piccolo Stato. Sul piano tecnico, distingue con nettezza legge costituzionale, legge qualificata e regolamento consiliare, chiedendo di usare ciascuno nel proprio ambito. Riconosce la cura posta nel Collegio Garante e suggerisce di valutare un ricorso diretto per lesioni gravi dei diritti. In materia europea, afferma che la sovranità si rafforza attraverso rinunce consapevoli e indica meccanismi per la fase ascendente e per la fase discendente. Chiude richiamando la “regola del gioco” democratica: maggioranza e minoranza si ascoltano e rispettano, a tutela dell’interesse generale.
Spazio successivamente all’intervento di Glauco Giostra, presidente del Collegio Garante della costituzionalità delle norme nella Repubblica di San Marino. Giostra apre il suo intervento esprimendo un apprezzamento per la legge istitutiva della Commissione di Riforma Istituzionale, sottolineandone l’impostazione inclusiva e la consapevolezza della necessità di coinvolgere tutte le forze politiche in un percorso che riguarda l’intera comunità sammarinese. Concentrandosi poi sul Collegio Garante, ambito a cui riserva il suo principale contributo, Giostra riconosce la funzione fondamentale dell’organo, ormai consolidata nella consapevolezza collettiva. Tuttavia segnala il disagio dei membri supplenti, che pur dovendo studiare l’intero ordinamento sammarinese non dispongono di un ruolo pienamente valorizzato. Propone perciò di assegnare loro competenze specifiche per materia, oppure di introdurre un percorso di progressione in cui, dopo un periodo di due anni, possano diventare membri effettivi. In alternativa, suggerisce una revisione della struttura del Collegio con un numero minore di componenti. Sui procedimenti di legittimità costituzionale, invita a procedere con prudenza. Non condivide l’ipotesi di introdurre l’“amparo” perché genererebbe un eccesso di contenzioso difficile da gestire. Sulla disciplina dei decreti-legge, osserva che non basta insistere su formule come “necessità e urgenza”, poiché ciò che conta è il controllo tra poteri e l’effettivo intervento del giudice costituzionale. Propone di introdurre l’istituto dell’amicus curiae, che permetterebbe a esperti qualificati di contribuire al dibattito in sede di giudizio costituzionale. Suggerisce l’istituzione di un ufficio stampa del Collegio per comunicare decisioni in modo sobrio. Chiude con un appello: innovare senza demolire, crescere “appoggiandosi” alla tradizione e migliorandola per passi successivi, equilibrati.
Alle 13.00 i lavori vengono interrotti. Riprenderanno alle 14.30.
Di seguito una sintesi dei lavori
Comma 2 – Audizioni
Professori Guido Guidi: In qualche modo farò una sommaria esposizione di tutte le problematiche che poi ho avuto l’ambizione, o comunque il coraggio, di mettere per iscritto in una pubblicazione uscita recentemente sulle riforme istituzionali. È ovvio che l’esposizione odierna, per quanto mi riguarda, è del tutto sommaria, e quindi su certi temi specifici mi sento di consigliare che la Commissione dovrebbe fare degli approfondimenti mirati per temi. Faccio un esempio per tutti: la problematica delle fonti non può essere trattata, in questa circostanza, in un’audizione che ha ad oggetto tutte le tematiche della riforma. Mi permetto di dire che un esame mirato sulla problematica delle fonti, a mio giudizio, sarebbe molto utile. Ma un tema di questo genere probabilmente, o sicuramente, dovrebbe formare anche oggetto di partecipazione della cittadinanza intera. Mi rendo conto che temi di questa portata, per il tecnicismo e la complessità delle questioni, non sono facilmente digeribili né in grado di catturare l’attenzione della cittadinanza. Però credo anche che, se la cittadinanza non partecipa a queste iniziative, perderebbe qualcosa. Parlando con il Segretario all’Università, egli mi diceva: “Verrebbe lei a illustrare queste cose nelle scuole?”. La mia risposta è stata di massima disponibilità, proprio in questa logica di partecipazione della cittadinanza. Partirei dalla premessa che avete posto nelle prime righe della legge qualificata approvata nel mese di gennaio, dove avete indicato la prospettiva strategica dentro la quale vi muovete, e avete sottolineato la conservazione, o semmai il potenziamento, della centralità dell’Assemblea Consiliare. Il Consiglio Grande e Generale è sempre stato, non con questa denominazione, il centro del sistema istituzionale di San Marino. È nella tradizione della Repubblica avere nell’organo collegiale consiliare il fulcro del sistema. Alle origini, per quanto riguarda l’attività legislativa il Consiglio era il centro dell’attività amministrativa e di governo. San Marino non ha mai avuto il processo di evoluzione delle istituzioni che invece si riscontra in Italia, dove il processo è inverso: prima nascono i governi e gli organismi di amministrazione, e successivamente le funzioni legislative in Parlamento. Qui il discorso è inverso: nasce originariamente il potere che viene ubicato all’interno del Consiglio, certo non nella forma democratica e rappresentativa di oggi, ma comunque sempre plurale e collegiale. È questa la tradizione di San Marino. Il Congresso di Stato è l’istituzione più giovane della Repubblica, perché risale al 1945, con la legge di riforma dei poteri pubblici, a seguito dell’istanza d’Arengo del 1919 presentata dal gruppo socialista, che lamentava la mancanza di un centro coordinatore: le funzioni amministrative erano collocate su una miriade di commissioni e organismi plurali che non avevano un centro. La nascita del Congresso è stata poi formalizzata nel 1945. Quindi un’evoluzione storica completamente diversa rispetto a tutte le altre democrazie europee. Oggi San Marino conferma questa prospettiva e il consolidamento della centralità, in un contesto europeo in cui invece si parla di riforme costituzionali in una prospettiva radicalmente diversa rispetto alla vostra. In Italia si discute di premierato; in Europa, cinquant’anni fa, in Francia si parlava di semipresidenzialismo; la tradizione britannica è il premierato; la tradizione tedesca è il cancellierato. Tutti sistemi in cui il tema centrale è la governabilità. Voi, invece, avete affrontato un’altra questione che non esclude la governabilità, ma avete detto: innanzitutto serve la stabilità. In questo, devo dire che le riforme introdotte nel sistema elettorale con due interventi successivi, mi portano a dire che l’assetto che ne è derivato è una formula valevole e convincente. Magari con ulteriori accorgimenti, ma avete ottenuto quella stabilità che in Italia deve ancora essere raggiunta, dove si ricerca con l’ipotesi di un premierato che presenta una miriade di problemi. Dove c’è lo scioglimento anticipato, cosa può accadere? Si va alle elezioni: in Francia si sarebbe forse tornati alle urne, si sarebbe ottenuta una maggioranza di poli estremi che avrebbe richiesto nuove elezioni. Ma questo succedersi automatico di scioglimenti nei sistemi può essere negativo, perché porta all’anarchia. Mi permetto di dare questa segnalazione. San Marino, per fortuna, non ha corso, non corre e non correrà questo problema. Tuttavia, guardando al meccanismo dello scioglimento automatico, mi sento di dire, osservando il diritto comparato, che nel contesto europeo non esiste. Non esiste perché può creare difficoltà, può generare continui scioglimenti e ipotesi anarchiche. Torno allora alla mia scaletta. La centralità del Consiglio Grande e Generale è legata alla tradizione, e qui sorge la solita questione: il conflitto tra tradizione e innovazione. Questo confronto, questa competizione culturale tra il conservare la tradizione e l’innovare, è un tema che esiste anche qui, è sempre esistito nella storia. La storia di San Marino, quella democratica, è piena di queste contrapposizioni. Tra tradizione e innovazione non può esserci una competizione “aut aut”, perché sono due valori che devono coesistere. Voi mi direte: qual è il parametro per stabilire dove restare legati, dove conservare e dove innovare? La Carta dei Diritti non lo dice, perché nel preambolo parla semplicemente di “continuità della vita dello Stato e delle sue istituzioni”. Il preambolo della Carta dei Diritti del 1974 parla di continuità, e ciò significa anche tradizione. Nel dibattito si avverte la presenza di tradizionalisti, storici e innovatori. Tradizione e innovazione devono trovare un momento di sintesi. Il problema è individuare qual è l’equilibrio, il punto di congiunzione, la sintesi tra tradizione e innovazione. Ma qual è il punto in cui trovare il momento di sintesi? Quando parlo di questi temi ai miei studenti, cito un personaggio che non ha nulla a che fare con il diritto, ma è un musicista, un direttore d’orchestra: Gustav Mahler, fine Ottocento. Gustav scrive: “La tradizione non è l’adorazione delle ceneri, ma la trasmissione del fuoco.” La differenza può essere questa: più passa il tempo, e più qualche volta le cose diventano di valore. Il vino invecchiato è più buono del vino giovane ma richiede un’attenzione particolare, perché a volte il vino invecchiato diventa aceto. E allora, se il vino invecchiato ha la qualità di essere vivo, vero, attivo, produttivo, la tradizione va conservata. Se invece è inerte e spenta, la tradizione va abbandonata. Voi avete fatto la scelta di conservare la centralità del Consiglio Grande e Generale, e questo è fuoco: un fuoco legato alla tradizione, ma selezionato nella sua funzione democratica attuale. A questa va aggiunto un altro pregio: quello di fare di un organo collegiale, non monocratico ma plurale e pluralista, il centro del concorso dell’intera cittadinanza nel determinare le scelte fondamentali della Repubblica. Che cosa significa però oggi “centralità del Consiglio Grande e Generale”? Significa affermare la centralità del sistema dei partiti. Le critiche al sistema dei partiti sono state e sono sempre latenti. La disaffezione al voto ne è una conseguenza: in Italia oggi vota meno del cinquanta per cento degli aventi diritto. È questo il segnale dell’inadeguatezza, talora, del sistema dei partiti a interpretare la società. La mediazione del sistema dei partiti è un valore. Apro e chiudo una parentesi: in questi giorni c’è stato un referendum in Italia. I referendum abrogativi devono raccogliere cinquecentomila sottoscrizioni. Una cosa è raccogliere cinquecentomila firme andando dal segretario comunale o da un notaio, un’altra è farlo dalla tastiera del proprio computer. Oggi in Italia è molto più facile avere accesso ai referendum perché la sottoscrizione avviene in via telematica. In alcuni casi, si immagina di sostituire con esse la partecipazione popolare, delegandola esclusivamente alla rete. In questo senso dobbiamo riconoscere che i partiti hanno tutti i limiti che hanno, ma non possiamo farne a meno. Partiti uguale democrazia. Fuori dai partiti c’è un’altra cosa. Dunque, dire “centralità del Consiglio Grande e Generale” significa dire “centralità dei partiti”, con tutte le obiezioni che si possono muovere a questo ruolo così grande dei partiti, ma è l’unica soluzione possibile per salvaguardare la democrazia. E allora, proseguendo, mi sono domandato di fronte al grande peso dei partiti, se non sia necessario valorizzare le istituzioni accanto ai partiti, senza fare dei partiti il soggetto unico e ultimo della decisione politica. Bisogna valorizzare le istituzioni. Quando avete scritto di voler valorizzare le funzioni istituzionali e di garanzia della Reggenza, sono convinto che abbiate pensato proprio a questo: a un organismo che avesse strumenti, forza e autorevolezza. L’autorevolezza la Reggenza ce l’ha, la forza meno. Avete pensato alla Reggenza come al luogo in cui rafforzare le funzioni istituzionali, cioè come garante del funzionamento del sistema, al di là e al di sopra dei partiti. Conservare in capo alla Reggenza la presidenza del Consiglio dei XII, mi permetto di dire, svaluta il peso della Reggenza. Il Consiglio dei XII, se storicamente ha assolto funzioni giurisdizionali eccezionali, oggi non le esercita più. Attribuire la presidenza di un organismo con funzioni amministrative alla massima carica dello Stato, dotata dell’autorevolezza e del prestigio che le competono, non è un riconoscimento di poteri, ma una diminuzione del ruolo. Anticipando quindi qualcosa anche sulla Reggenza, dico quali sono le altre considerazioni che emergono dalla legge istitutiva della Commissione. Voi avete indicato il rafforzamento del ruolo dei consiglieri, e questo va interpretato in questa stessa logica: rafforzare il ruolo dei consiglieri non come semplice catena di trasmissione del partito, ma come figure dotate di autorevolezza, cultura, prestigio e libertà, perché rappresentano la nazione intera. Il consigliere deve essere valorizzato in quanto tale, non solo in quanto membro di un partito o di un gruppo parlamentare. Ho sentito nei vostri interventi anche l’idea di riconoscere un’indennità ai consiglieri. Non ho alcuna pretesa di dare sentenze, ma posso riferire ciò che avviene nel diritto comparato. Si riscontra che tutti i piccoli Stati riconoscono un’indennità mensile ai membri dei propri parlamenti. A mio giudizio, e qui introduco un tema non so se mai discusso, la Carta dei Diritti di San Marino non contiene il principio del divieto di mandato imperativo. Il consigliere è eletto in una circoscrizione, ma rappresenta la nazione; quindi, non ha il dovere di eseguire il mandato elettorale. Sono andato a vedere la formula statutaria che voi, quando siete eletti, dovete pronunciare. Ricordo di averla pronunciata anch’io, come giudice: “Sopra i Santi Evangeli giuro e prometto perpetua fedeltà ed obbedienza alla Costituzione e mi impegno di nominare e di dare il mio voto a persone soltanto che crederò abili, fedeli e idonee a prestare buon servizio alla Repubblica, senza lasciarmi trasportare da alcuna passione di odio, amore o da ogni altra.” Che cos’è questo, se non il divieto del mandato imperativo? Voi non avete introdotto una formula formale. Non c’è il divieto del mandato imperativo, però, quando andiamo a sfogliare le costituzioni di tutti gli Stati, e in particolare dei piccoli Stati, troviamo che San Marino non ha questo divieto. Allora mi domando anche: perché? Molte volte le Costituzioni hanno la funzione di rendere trasparente il sistema, all’interno e all’esterno. E allora, perché non renderlo palese? Mi pongo il problema di chi osserva San Marino dall’esterno e guarda la Carta dei Diritti, e si chiede: “Non c’è il divieto del mandato imperativo?” In realtà, San Marino lo ha, formulato in questa maniera statutaria, e lo ha pensato già prima di tanti altri. Detto questo, devo però fare una piccola critica, se me lo consentite. In questa logica di rafforzamento delle istituzioni di fronte ai partiti, credo si debba rafforzare la dimensione istituzionale rispetto al partito. Sono andato a vedere la nostra legge del 2005 sul finanziamento dei partiti, la Legge n. 170 del 2005, dove è scritto che tra i ruoli dei partiti c’è anche quello di assolvere funzioni nell’ambito degli organi istituzionali dello Stato. Trovo, sul piano formale, questa affermazione un po’ eccessiva, e forse meritevole di una attenuazione. Come? Molto semplicemente: come avviene nel diritto comparato, dove il finanziamento ai partiti non viene dato direttamente ai partiti, ma ai gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari sono componenti non della società civile, ma della struttura pubblica nella quale si organizza la società civile. E allora, se io do il finanziamento pubblico ai gruppi parlamentari, è come darlo al partito politico: poi il gruppo lo gestirà come ritiene, per l’organizzazione interna o esterna. Ma, sul piano formale, riconoscere che il finanziamento non va dato a un soggetto esterno alle istituzioni, rafforza la valorizzazione delle istituzioni nei confronti del partito politico, senza togliere nulla al peso del partito stesso. Qui arriviamo a un punto centrale, sul quale non ho risposte, ma solo dubbi. Come si potrebbe dare un peso istituzionale al di sopra dei partiti, al Congresso? La solita proposta è quella di creare un Premier, un Presidente, un Capo, un Consiglio dei Ministri. A mio giudizio, però, questa soluzione è lontana dalla tradizione sammarinese, fondata sul principio di collegialità, che si traduce, per quanto riguarda il Congresso, nell’assenza di un capo formale. Storicamente, una delle prime cose che ho imparato è che il Segretario agli Esteri e il Segretario agli Interni hanno un peso specifico superiore rispetto agli altri, ma non hanno la rappresentanza del Governo, che di volta in volta viene affidata a chi il Congresso ritiene opportuno designare. Nel mio libro ho avanzato qualche idea. Che cosa mi era venuto in mente? Vedete, in Gran Bretagna, ciò che noi chiamiamo “governo” è in realtà composto da due organi: il “Government”, circa trenta persone, e il “Cabinet”, trentaquattro persone, dove siedono i riferimenti politici principali che formano la maggioranza e i ministri più significativi. Non è questo il modello che propongo per San Marino, ma lo pongo come provocazione, sapendo già le obiezioni che mi farete. Perché non prevedere che i segretari di partito, oltre a essere segretari di partito, siano anche membri del Congresso? Metto solo in luce i possibili vantaggi: se nella conduzione dell’attività del Congresso si verifica un blocco, una paralisi, una disparità di vedute tra i membri, non occorrerebbe prendere il telefono e chiamare i segretari di partito: sarebbero già presenti all’interno delle istituzioni, con una presenza istituzionale diretta. Questo, però, va contro la logica della partecipazione, della divisione dei compiti, dei doveri e delle aspettative che esistono all’interno dei partiti. Tutte obiezioni legittime, che conosco. Perciò la pongo solo come provocazione. Detto ciò, questa strategia di centralità del Consiglio ci porta a chiederci: che cosa c’è, nelle istituzioni sammarinesi vigenti, di veramente centrale, e che cosa invece rappresenta una negazione o un contrasto a questa logica della centralità? La forma di governo parlamentare-assembleare, così la definiamo, fonda la dipendenza del Governo in modo rigido dall’esistenza di una maggioranza consiliare. Questa è una conferma della centralità. Nulla è immodificabile, ma questa è una tradizione consolidata. Cos’altro è centrale nella forma di governo sammarinese? Il Consiglio non è solo luogo della legislazione, ma anche luogo in cui si amministra, si governa. Soprattutto, il Consiglio esprime un notevole numero di commissioni, con compiti a volte amministrativi, a volte consultivi, a volte propositivi, che esulano dalla mera attività legislativa. Le commissioni, e in generale l’attività amministrativa in senso lato del Consiglio, la valorizzano. Il Consiglio è centrale: viene meno la maggioranza, il Consiglio viene sciolto; se non si esprime una nuova maggioranza e si rompe l’accordo, scatta lo scioglimento. È un altro elemento di centralità attuata. Le fonti normative, con le critiche che voi stessi avete fatto e che avete scritto nella legge qualificata istitutiva della Commissione, richiedono alcuni aggiustamenti sul decreto legge e sulla legge delegata. Alcune correzioni le avete già indicate: sulla legge delegata avete già scritto cosa occorre fare, è già tutto definito; sul decreto legge avete solo prospettato la questione dell’abuso di questo strumento, legato al requisito dell’urgenza, e quindi anche lì ci sarà qualcosa da fare. Nella strutturazione del Collegio Garante, voi avete ribadito la centralità del Consiglio. Basta ricordare com’è composto: il Collegio Garante è formato dal Consiglio Grande e Generale a tempo determinato, con maggioranza dei due terzi, rinnovo parziale per un terzo ogni due anni, rotazione della carica del presidente con l’obiettivo di evitare eccessive concentrazioni di potere. Quanta cura nel delineare il Collegio Garante, quanta attenzione. Ed è una norma scritta nella Carta dei Diritti. Qui viene ribadito in modo autentico il ruolo di centralità del Consiglio Grande e Generale. E poi ci sono altri poteri del Consiglio che ne affermano la centralità. Quando leggiamo che la questione di costituzionalità sulle leggi votate dal Consiglio può essere sollevata anche da parte di venti consiglieri del Consiglio Grande e Generale, significa ancora una volta valorizzare il Consiglio, anche nella sua componente minoritaria. Detto questo, devo però rilevare che nell’attuale assetto dei poteri esiste anche un affievolimento della centralità. Dove riscontriamo questo indebolimento? Lo abbiamo già detto: nei decreti legge e nelle leggi delegate. Ma, per esempio, oggi i giudici sono completamente sottratti alla elezione da parte del Consiglio Grande e Generale, e questa, almeno sul piano concettuale, rappresenta una difformità rispetto alla logica della centralità del Consiglio. Un altro affievolimento riguarda la previsione di tutta una serie di istituti di democrazia diretta, di referendum, che posso dire che non hanno precedenti nel contesto mondiale. Il sistema dei referendum adottato da San Marino include referendum interrogativi, confermativi, introduttivi, insieme alle istanze d’Arengo e agli altri strumenti di partecipazione diretta. Tutti questi istituti di democrazia diretta significano, in parte, sottrarre poteri di centralità al Consiglio, seppur in bona parte, in questo caso. Tuttavia, la mia segnalazione non è negativa. Nel diritto comparato la vicinanza tra eletto ed elettore nei piccoli Stati è tale che si riscontrano pochissime formule referendarie. Andorra, Liechtenstein, Monaco, Malta: pochi istituti referendari. San Marino, invece, è all’avanguardia in questo senso, su tutti. Quindi non voglio essere frainteso: la mia considerazione non è negativa, ma è una constatazione. A fronte della scelta strategica di fare del Consiglio l’organo centrale, qui si registra una sottrazione, una redistribuzione di centralità verso i detentori diretti della sovranità. Attenzione ad adottare formule istituzionali che hanno dato buoni risultati nei grandi Stati. Piccoli Stati e grandi Stati sono due dimensioni statali differenti, che richiedono grande cautela nell’imitare formule istituzionali magari efficaci altrove, ma potenzialmente deleterie in un contesto come il vostro. Ogni tanto, qualche atto di soggezione istituzionale nei confronti dell’estero, in particolare dell’Italia, lo abbiamo avuto. E qui mi sento di essere molto netto: quando si decide di introdurre un istituto, un procedimento, una riforma o un’innovazione, non bisogna dire “andiamo a vedere fuori”. No: l’Italia non fa testo. Vi vorrei dare qualche testimonianza di come l’introduzione acritica di istituti presi dai grandi Stati, in realtà, non faccia bene ai piccoli Stati. Tutti i grandi Stati hanno un Parlamento bicamerale. Tutti i piccoli Stati hanno un Parlamento monocamerale. Ci sarà una ragione. Immaginate di ipotizzare, guardando all’estero, un Parlamento bicamerale a San Marino. Questo comporterebbe, da parte nostra, una riflessione profonda, perché il bicameralismo è inadatto a San Marino. Esso assolve a funzioni che qui non ci sono e che non siamo in grado di svolgere con una sola assemblea. Quali sono le funzioni del bicameralismo? La rappresentanza di territori omogenei con identità particolari, con connotati linguistici, talvolta etnici, territoriali o economici. San Marino, invece, presenta un’omogeneità territoriale: non ci sono diversità di questo tipo. Quindi, il bicameralismo non ha senso. Tuttavia, il bicameralismo ha anche un’altra funzione, che è quella di fungere da freno alla dittatura dell’assemblea, perché anche le assemblee possono sbagliare, anche i parlamenti possono sbagliare. E se esiste una doppia Camera, la seconda può correggere ciò che è avvenuto nella prima. Ed è questa la grande differenza che esiste tra le problematiche dei piccoli e dei grandi Stati. Nei piccoli Stati, per esempio, non ho mai visto — e San Marino non ha mai avuto — partiti territoriali, cioè partiti in cui qualcuno si faccia interprete degli interessi di Dogana o di Acquaviva. E San Marino non ha mai avuto nemmeno — anche se l’espressione può prestarsi ad ambiguità — dei partiti personali. Molte politiche pubbliche che oggi sono al centro del confronto politico europeo, e che dominano il dibattito politico degli Stati dell’Unione, non esistono a San Marino. In Italia, e in tutta Europa, oggi i ventisette Stati stanno cercando di rimediare all’interno dei propri bilanci statali, spostando risorse dal welfare alla difesa. San Marino non ha queste problematiche. San Marino non ha neppure la necessità di prevedere sforzi di bilancio a favore di aree depresse, come accade in Italia. Il territorio di San Marino, per fortuna, non presenta squilibri territoriali e non richiede politiche differenziate. San Marino non affronta i problemi che oggi sono al centro del confronto politico italiano ed europeo: il problema dell’immigrazione, del multilinguismo, del multiculturalismo. Sono questioni che oggi scuotono tutte le democrazie europee. Questo conferma quanto sia necessario tenere conto della differenza tra piccoli e grandi Stati. La magistratura di carriera è una modalità di selezione propria dei grandi Stati. L’Italia ha novemila giudici; tutti i Paesi maggiori ne hanno seimila o settemila. Alcuni hanno una magistratura di carriera. San Marino ha una magistratura di carriera, il che significa una continuità nell’esercizio della funzione giurisdizionale negli anni, che può creare qualche difficoltà. Faccio un esempio. In Italia esiste l’istituto dell’incompatibilità ambientale del giudice. Non parliamo di questioni disciplinari o di incompatibilità legali, ma di un fenomeno oggettivo: un giudice che vive e lavora in una certa giurisdizione può avere contatti con la stampa, con l’economia, con le istituzioni. Di fronte a situazioni del genere, in Italia si applica l’istituto dell’incompatibilità ambientale, che è un istituto ordinario. Ma in un piccolo Stato, dove un giudice mette radici, questa vicinanza naturale, umana, con il tessuto sociale può creare condizioni di incompatibilità ambientale, anche senza colpa o responsabilità. Per la mia esperienza di giudice, sappiamo quanto spesso i procedimenti si blocchino per una ricusazione o per un’astensione, con continui rinvii e sospensioni. In Italia è più semplice: quando esistono contatti naturali e inevitabili tra un giudice e la società civile, interviene l’istituto dell’incompatibilità ambientale. Non è una punizione, non è una sanzione, non comporta alcun giudizio disciplinare, ma riconosce la necessità che il magistrato svolga le sue funzioni in un contesto diverso. Sull’accordo di associazione. Qui devo dare un giudizio politico, se me lo consentite, pur non essendo un politico. Questo è un tema che domina anche in Italia, dove esistono i cosiddetti “sovranisti”, gli oppositori dell’Unione Europea. In forma lapidaria, mi sento di dire questo: il rafforzamento della sovranità degli Stati, paradossalmente, passa attraverso alcune rinunce alla sovranità. Il rafforzamento della sovranità passa attraverso una consapevole riduzione di alcuni connotati della sovranità nazionale. Potremmo aprire una grande discussione sul concetto di sovranità. Oggi constatiamo delle oggettive perdite di sovranità che non abbiamo deciso, ma che ci vengono imposte dai fatti. Ve ne cito solo alcune, che conoscete meglio di me. La sovranità dell’Ucraina — che non è in Europa, ma serve da esempio — è garantita da Starlink, la rete satellitare di Musk. E poi l’invadenza delle big tech, la conoscete benissimo, e poi l’invadenza dell’intelligenza artificiale. Da soli non possiamo contrastare questi fenomeni. Non lo può l’Italia, non lo può San Marino, non lo può l’Europa. E quindi la rinuncia, in certi consapevoli ambiti di sovranità, è il presupposto per la conservazione della sovranità. Chiudo: la difesa. L’Italia non è in grado di difendersi nassa. L’Europa non è in grado di difendersi da sola. È anche qui un altro esempio. Che cosa va fatto all’interno di San Marino? Prendere atto, sul piano normativo, di questa necessità di una consapevole rinuncia ad alcuni aspetti della sovranità. Lo dico non come affermazione di principio politico, ma come riscontro di ciò che avviene nel diritto comparato, dove tutti i Paesi europei hanno introdotto nella Carta dei diritti brevi regole in cui si dicono rinunce: rinunce alla propria sovranità negli ambiti trasferiti all’Unione Europea. E quindi l’articolo 2 della Carta dei diritti dovrebbe prevedere una qualche formula di questo tipo. Alcune Costituzioni, non quella italiana, sulla problematica europea prevedono la partecipazione, anzi il doveroso coinvolgimento, dei governi e dei parlamenti nazionali nella fase ascendente di formazione del diritto comunitario. Che cosa vuol dire? Regolamenti e direttive dell’Unione Europea sono emanati all’interno degli organismi europei e valgono negli ordinamenti nazionali. I Parlamenti vogliono concorrere alla formazione di questa volontà europea: nella fase ascendente, dallo Stato alle istituzioni europee, devono poter avere un canale attraverso cui comunicare la propria posizione e il proprio punto di vista sulle leggi europee che poi avranno un riverbero su di me. La fase ascendente è molto delicata perché, mentre sono ventisette gli Stati che concorrono alla fase legislativa, l’Italia, per esempio, partecipa alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario per il dato oggettivo che i ministri del governo italiano siedono all’interno del Consiglio dei ministri dell’Unione Europea. San Marino non siede dentro gli organi di governo e legislativi dell’Unione Europea. Non è membro: è associato. Non partecipa alla fase ascendente. Come possiamo incidere in fase ascendente sulla formazione del diritto europeo che ci riguarderà? Sistematicamente gli uffici della Commissione trasmetteranno allo Stato le iniziative legislative in itinere. Il Consiglio Grande e Generale, il Congresso elaborano le proprie osservazioni. E poi? Non c’è il Segretario agli Esteri che siede nel Consiglio dei ministri. Cosa facciamo? Innanzitutto, dovremmo concertarci con Andorra, visto che gli accordi, come ben sapete e insegnate, vedono assieme l’associazione dei due Stati. Formulare proposte in sede consultiva ed avere l’intervento dei buoni uffici di uno Stato estero — sarà l’Italia — che si faccia carico delle nostre esigenze. Questo è un lavoro diplomatico, istituzionale, che richiede continuità: richiede una presenza all’interno degli organismi europei che sia tempestiva. Questa è la fase più delicata, sulla quale bisogna ragionare, affinché ci siano istituzioni locali in grado di assolvere questa funzione: recepire, passare alla parte politica quali sono le criticità, elaborare soluzioni tecniche alternative, mediare per ottenere un intermediario che possa farsi carico delle esigenze nazionali. E poi c’è la fase discendente. Per fase discendente delle iniziative europee si intende questo: la normativa europea non ha efficacia diretta nell’ordinamento interno. Attenzione: a differenza di quanto si potrebbe pensare, non ha efficacia diretta non solo per quanto riguarda le direttive, ma anche per quanto riguarda i regolamenti. Né i regolamenti europei né le direttive hanno efficacia diretta: non è come per i membri. Noi siamo associati; quindi regolamenti e direttive dovranno volta a volta essere recepiti con una formulazione sovrana che tiene conto delle linee direttive della legge europea. Detto ciò, ecco che cosa ha istituito l’Italia: c’è una Commissione parlamentare che si occupa di queste cose, la Commissione parlamentare per le politiche dell’UE, una Commissione ad hoc, la quale potrebbe sovrintendere a tutte le attività e ai provvedimenti che riguardano l’attuazione dell’accordo. Questo dovrà essere il filo. Ancora una volta: centralità. Sarà il Consiglio a dover, attraverso questa Commissione, essere il ricettore. Ecco qui il tema delle fonti. Ho già detto prima: il tema delle fonti giuridiche è di una complessità tale per cui, se riterrete di parlarne, mi permetto di dire che sarebbe una buona cosa. Noi abbiamo la legge costituzionale e la legge di revisione costituzionale indicate in ventidue articoli. Che cosa le unifica? La procedura: la maggioranza dei due terzi. Se non c’è la maggioranza dei due terzi, si ricorre al referendum costituzionale. L’ambito della legge costituzionale e della revisione è questo: che cosa dobbiamo fare con legge costituzionale e che cosa dobbiamo fare con la revisione della Carta dei Diritti. Può sembrare una questione formale, ma non lo è affatto. Domanda: posso usare la legge costituzionale senza intervenire sul testo formale della Dichiarazione dei Diritti anche in altre materie? Noi lo abbiamo fatto. Possiamo farlo? Il diritto comparato ci dice di no. San Marino lo ha fatto. La rigidità della norma può essere un pregio, ma qualche volta può essere un difetto, se si introduce rigidità dove servirebbe flessibilità. Se il costituente sammarinese ha stabilito che “questo si fa con legge costituzionale” e “questo si fa con legge qualificata”, lo ha fatto in modo meditato. Io sono tra coloro che ritengono che la legge costituzionale dovrebbe essere impiegata sulla base delle riserve di legge scritte nel testo della Dichiarazione dei Diritti. E poi c’è la legge qualificata. Legge qualificata e regolamento consiliare sono entrambi approvati a maggioranza qualificata del Consiglio Grande e Generale. Ma, pur essendo unificate dalla medesima procedura, sono distinte per oggetto e materia. Le leggi qualificate le indica la Carta dei Diritti; il regolamento, invece, riguarda le materie che la Carta dei Diritti rimanda esplicitamente al regolamento stesso. Osservo che, talvolta, il Consiglio, nel modificare il regolamento parlamentare, lo ha fatto ricorrendo alla legge qualificata. Mi permetto di dire che questo non è corretto. La modifica del regolamento si fa con il regolamento parlamentare, che la Carta dei Diritti indica come approvabile a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La natura giuridica delle fonti la determina la denominazione. Se scrivo “Legge qualificata”, quella è una legge qualificata; se scrivo “Regolamento consiliare”, è un regolamento consiliare. Cambia molto per una ragione precisa: se leggiamo quali sono gli atti impugnabili davanti al Collegio Garante, vediamo che c’è la legge qualificata, ma non il regolamento consiliare. E allora accade che il vostro regolamento consiliare possa diventare impugnabile davanti al Collegio Garante solo perché lo avete adottato con la forma della legge qualificata, mentre — a mio giudizio — sarebbe stato più corretto approvarlo come regolamento consiliare. In questo modo non sarebbe impugnabile davanti al Collegio. I regolamenti parlamentari non possono essere sindacati da un giudice. Un giudice non può interferire con i criteri di formazione della volontà parlamentare, che è l’espressione diretta della sovranità popolare. Quindi il regolamento consiliare non deve essere elencato tra gli atti soggetti a controllo di costituzionalità. Oggi, invece, il regolamento consiliare è impugnabile davanti alla Corte costituzionale nei casi in cui sia stato adottato con la formula formale della legge qualificata, la quale, in quanto tale, la Carta dei Diritti considera impugnabile. Qualcosa sul Collegio Garante, molto sinteticamente. Devo riconoscere la grande sensibilità con cui è stato disciplinato questo istituto, pur con possibili correzioni e aggiustamenti. La vastità dei soggetti legittimati a impugnare le leggi non si trova in altri ordinamenti: un gran numero di soggetti è indicato come legittimato a sollevare la questione di costituzionalità. Per i miei connotati culturali, mi ha molto sorpreso favorevolmente una modifica che avete introdotto nel 2005, inserendo tra i soggetti che possono sollevare la questione di costituzionalità la Commissione per le Pari Opportunità. Magari sarà piccola cosa sull’oggetto; non è piccola cosa, è grande cosa. Sul piano concettuale è una grande cosa, perché prevedere la legittimazione attiva a investire il Collegio Garante da parte di un organismo associativo significa, sul piano concettuale, riconoscere che a San Marino i diritti di libertà non sono solo del singolo, ma anche delle associazioni e dei fenomeni associativi, come diciamo noi in unità delle formazioni sociali. Avete riconosciuto la legittimazione attiva non solo ai singoli, ma anche a formazioni sociali. Sul piano concettuale questo è molto rilevante: abbiamo sempre studiato i diritti fondamentali dell’uomo e della donna, cioè attribuiti ai singoli; qui avete riconosciuto diritti fondamentali a un soggetto con valenza giuridica collettiva. Che cosa mi sento di proporre — non come indicazione politica, ma come informazione dal diritto comparato? Il cosiddetto ricorso diretto al Collegio Garante: noi non l’abbiamo. Abbiamo l’impugnazione in via principale della legge, l’incidentale, i conflitti, e altri compiti assegnati da leggi successive. Non abbiamo il ricorso diretto; non ce l’ha neanche l’Italia. Che cos’è il ricorso diretto al Collegio Garante? È previsto in molti ordinamenti europei, anzitutto in Germania: a fronte di un atto gravemente lesivo delle libertà personali, si può andare davanti alla magistratura ordinaria, ma anche direttamente alla Corte costituzionale. Se una persona è stata detenuta irregolarmente e ritiene iniqua la decisione del tribunale ordinario, è possibile un rimedio straordinario al Collegio Garante. San Marino non ce l’ha; la Germania ce l’ha. Il senso è: se qualcuno si ritiene leso in un diritto fondamentale, al di sopra dei giudici ordinari può rivolgersi alla Corte costituzionale perché la menomazione è troppo grave. Lo sottopongo alla vostra attenzione. Un’altra questione: il Collegio Garante si occupa anche dei conflitti tra organi costituzionali. Quali sono gli organi costituzionali? Certamente Consiglio, Congresso, lo stesso Collegio Garante, la Magistratura. Mi domando: il Collegio per la Finanza Pubblica, approvato con legge, è un organo costituzionale? Il Consiglio Giudiziario è un organo costituzionale? Qualcosa ho già detto su bicameralismo/monocameralismo. Noi non abbiamo due Camere, per fortuna: abbiamo un solo ramo del Parlamento, il Consiglio. Ma alcuni ruoli di contrappeso, riflessione, correzione, meditazione sono assolti favorevolmente dall’esistenza di due Camere. Quel ruolo del bicameralismo potremmo recuperarlo, a mio giudizio, anche in un modello monocamerale: certe funzioni proprie dei sistemi bicamerali possono essere utili anche qui. Come recuperarli mantenendo il monocameralismo, dato ineliminabile? Ricorrendo all’istituzione di alcune commissioni consiliari e procedimenti consiliari che, dall’interno dell’unica Camera, assolvano la stessa funzione di ripensamento e controllo. Mi avvalgo dell’esempio italiano: la Commissione per gli Affari Costituzionali verifica l’impatto dei progetti di legge sull’ordinamento costituzionale, cioè svolge una valutazione preventiva di conformità costituzionale dei progetti. Ancora dal diritto comparato italiano: sia alla Camera che al Senato esiste il Comitato per la Legislazione, che serve a valutare la qualità dei testi. Nel chiudere, presidenti, dirò quanto anche i buoni comportamenti siano determinanti. Non lo dico con parole mie, ma con quelle di Arturo Carlo Jemolo, che tenne l’orazione ufficiale nella Repubblica il 1° aprile 1949 per l’insediamento dei Capitani Reggenti Ferruccio Martelli e Primo Bugli. “La bellezza del contrasto politico ha come condizione che si resti fedeli alla regola del gioco. La regola del gioco sta in questi due comportamenti: da parte di chi ha tentato ma non è riuscito a conquistare la maggioranza, di non sentirsi nello stato d’animo del nemico vinto, bensì di sentirsi sempre cittadino, partecipe delle fortune dello Stato, conscio che non si opera soltanto nelle assemblee legislative ma ad ogni ora, concorrendo a formare quel supremo consesso che è l’opinione pubblica, e che tanto più si conquista l’opinione pubblica quanto più la propria parola e i propri giudizi siano pacati e privi di rancore. Ma la regola del gioco della democrazia esige anche molto da parte di chi ha vinto le elezioni: che essi, cioè, ricordino che c’è una minoranza, l’ascoltino, non deliberino cosa alcuna senza averla ascoltata e, per quanto sia possibile, le vengano incontro. Che ricordino che il popolo è costituito dalla maggioranza e dalla minoranza, e che i governanti devono cercare di sanare le ferite delle lotte passate, non di approfondirle.” Mi sembravano parole meritevoli di essere ricordate.
****
Professore Glauco Giostra: Io volevo in apertura esprimere un sincero apprezzamento per la legge istitutiva di questa Commissione di Riforma Istituzionale. A parte i contenuti, che sono inevitabilmente generici, una cosa che mi ha colpito è che vi si coglie la consapevolezza della necessità del concorso di tutte le energie politiche, perché il risultato riguarderà l’intera comunità sammarinese. Non è una legge che la maggioranza del momento fa per realizzare il proprio disegno politico: è qualcosa che riguarda tutti, e questo lo percepisco nel fatto che la maggioranza, nella Commissione, non può avere più dei due terzi, e che le delibere vanno prese con la maggioranza dei due terzi della Commissione. Quindi c’è comunque bisogno di un coinvolgimento dell’opposizione, anche perché, su questi temi, la maggioranza di oggi sarà forse la minoranza di domani, o potrebbe esserlo. Avendo avuto la fortuna di essere stato chiamato all’unanimità, non ho collegamenti di nessun tipo, e questo lo dico perché mi conosco: se c’è una cosa che mi contraddistingue è una certa rigidità rispetto a interferenze, pressioni, suggestioni. Quindi è meglio non conoscere, non sapere, perché noi siamo chiamati a giudicare in base al diritto. Facciamo i nostri errori, ovviamente in buona fede, a prescindere. L’altra cosa che vorrei dire in apertura è che il miglioramento che vi accingete ad apportare al vostro sistema è indubbiamente necessario e, nel mio piccolo, proverò a dare qualche indicazione o suggerimento necessario, ma non sufficiente. Vorrei sottolineare che c’è una Costituzione materiale su cui richiamare la vostra attenzione. È importante che non ci sia delegittimazione reciproca tra soggetti pubblici, che non ci siano interferenze tra organi — rischio molto alto nei microstati — un rischio su cui richiamava l’attenzione anche il Presidente Canzio. Il rispetto delle istituzioni, la dialettica leale, è composta di contrapposizioni argomentative: uno argomenta contro la tesi dell’altro, non contro l’avversario; non demonizzando chi l’ha espressa, ma contestandola; non dileggiando chi la sostiene. Su questo richiamava efficacemente, in occasione del ventesimo anniversario del Collegio, il professor De Vergottini: l’assetto costituzionale, prima che nella carta, deve scorrere nelle vene del popolo e dei suoi rappresentanti. Perché anche il miglior testo normativo, se non è rilegato dalla coscienza collettiva, viene scompaginato alla prima folata emergenziale o dalla prima prassi deviante imposta dalla maggioranza del momento. Il mio contributo, anche se mi è stata data l’ampia possibilità di spaziare, si limiterà quasi esclusivamente a ciò che riguarda il Collegio Garante, perché è una materia a cui tengo. C’è una sindrome che probabilmente conoscete, molto diffusa in Italia, ed è stata studiata: la sindrome di Dunning-Kruger, quella per cui ci riteniamo tutti competenti a intervenire su tutto. Nei limiti del possibile, cerco sempre di limitare il mio campo, e questo significa limitare molto, perché le mie conoscenze sono contenute, circoscritte, lo riconosco, tanto più in un contesto come quello sammarinese, che conosco da poco. Da quanto ho letto, sia nella legge istitutiva che nella relazione accompagnatoria, le linee della riforma non incidono — anzi, semmai rafforzano — la funzione di irrinunciabile garanzia che, in una democrazia costituzionale, ha il Collegio Garante. Ormai, dopo qualche comprensibilissima resistenza iniziale al momento della sua istituzione, c’è piena consapevolezza della sua altissima funzione. Tutti riconoscono — al di là di errori, orientamenti discutibili, eccetera — l’importanza istituzionale e funzionale del Collegio. Nella relazione della legge istitutiva si richiama in particolare — anche se non esclusivamente — l’attenzione sulla composizione dell’organo e sulla disciplina della sua funzione elettiva, che è quella del sindacato di costituzionalità e della struttura del Collegio. Devo rappresentare, e ne sono particolarmente convinto, che abbiamo percepito, anche sentendo gli altri componenti del Collegio prima di incontrarvi, che già da tempo si registrano evidenti disagi da parte dei membri supplenti del Collegio. I membri supplenti devono fare, come gli effettivi, uno sforzo di studio dell’intero ordinamento sammarinese, che per gli esterni non è un impegno lieve. E siamo sempre, perlomeno io mi sento tale, un po’ inadeguati a questo compito, perché l’ordinamento ha una profondità, anche cronotemporale, che sfugge alla nostra capacità di controllare tutte le fonti. E c’è un altro membro supplente che ha preannunciato — spero ritratti — le dimissioni: l’avvocato e professore Manacorda, anche lui non a caso supplente. Perché avvertono — e qui mi sento di condividere — un certo disagio. E lo dico anche per rispetto verso nomi di altissimo profilo: fior di giuristi tra i supplenti. Non c’è, ovviamente, una graduatoria di merito: non è che i migliori siano gli effettivi e gli altri no. Però, di fatto, la percezione è un po’ questa, e viene vissuta con disagio. Allora, una proposta è che ai supplenti sia riservata una competenza specifica: ad esempio, uno si occupa solo di referendum, un altro solo di astensione degli organi apicali della magistratura sammarinese, un altro di altre materie. In questo modo, a un minore impegno istituzionale corrisponderebbe anche un minore onere di aggiornamento e di studio. Si potrebbe anche prevedere, per alcune materie, una competenza monocratica — cioè affidata a un singolo supplente — che permetterebbe di valorizzare il ruolo e migliorare la percezione, sia interna che esterna, del membro supplente. Questa idea, che vi sottopongo, è condivisa da almeno altri due componenti del Collegio a cui l’ho presentata. A mio modo di vedere, sarebbe opportuno prevedere un sistema in cui si nomina inizialmente solo supplenti, che poi diventano effettivi dopo due anni di esperienza. Dico questo perché vi ammiro molto, ma vedo la rapidità con cui vi succedete nelle cariche: i Capitani Reggenti ogni sei mesi, per esempio. Due anni, invece, permetterebbero a un supplente di maturare un’esperienza concreta, di rapportarsi con i colleghi, di studiare la giurisprudenza precedente, di comprendere meglio i gangli, i rapporti, le difficoltà e le implicazioni delle decisioni. Dopo questo periodo, il passaggio ad effettivo avverrebbe automaticamente. In alternativa, si potrebbe limitare la competenza e lasciare la struttura attuale. Qualcuno suggerisce anche che, se si introducono competenze per materia, si potrebbe ridurre il numero complessivo dei componenti — magari cinque, con solo due supplenti. Oppure mantenere la struttura attuale, ma con questa progressione di carriera. C’è poi un problema diverso, che pongo solo come spunto, perché è stato sollevato in occasione dell’anniversario dell’istituzione del Collegio Garante. È un tema più politico che tecnico: l’idea di prevedere come obbligatoria la presenza di un giudice sammarinese nel Collegio, oppure di stabilire un passaggio obbligato da giudice della Corte Europea a membro del Collegio, per valorizzare l’esperienza acquisita. Ripeto, lo dico solo come promemoria: a mio modo di vedere, è una valutazione politica. Si può apprezzare l’opportunità di avere una voce interna al circuito di pensiero del Collegio, ma d’altra parte qualcuno potrebbe dire che è meglio che, sulle questioni più delicate, il giudice sia esterno e non condizionato. Queste sono valutazioni politiche. Passando invece al procedimento, quello su cui giustamente la legge istitutiva richiama l’attenzione è il principale: il giudizio di legittimità costituzionale. C’è da cambiare qualcosa? Le proposte sono molte. Qualcosa, secondo me, si potrebbe fare, anche se bisogna procedere con prudenza da artificiere, perché si rischia di fare più danni che miglioramenti. È stato proposto di introdurre l’istituto dell’Amparo, cioè la possibilità per un singolo cittadino di investire direttamente il Collegio di una questione. Io non sarei favorevole, per quello che può contare, e mi pare che anche il presidente Canzio si fosse espresso contro. Credo che creerebbe diversi problemi di gestione: bisognerebbe disciplinare con estrema attenzione i criteri di ammissibilità, i presupposti e le condizioni, perché si rischierebbe una corsa al ricorso individuale. Diverso, invece, è il discorso del ricorso individuale diretto al Collegio da parte di soggetti implicati in procedimenti giudiziari, e non da un cittadino qualsiasi. Questa proposta, avanzata più volte — prima da altri e poi anche dall’avvocato Nicolini, a nome del mondo forense — nasce dal fatto che oggi i giudici “a quo”, cioè quelli che devono valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, filtrano troppo. Poiché l’avvocato Nicolini è persona molto competente e consapevole anche dei rischi, riconosce che si potrebbero introdurre sanzioni per i ricorsi temerari, così da evitare abusi. Immagino il ricorrente che dice “Signori del Collegio, voglio sollevare una questione di costituzionalità di questa norma e assumo che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.” Per il secondo requisito ci riuniamo, vediamo la norma censurata, il principio che sarebbe leso e, nei limiti dei nostri poteri, possiamo pronunciarci subito sulla non manifesta infondatezza. Ma sulla rilevanza nel processo dovremmo acquisire tutto il fascicolo. Immagino un andirivieni di fascicoli processuali, la sospensione del procedimento a quo, con il rischio di compromettere la funzionalità del sistema. Quindi, non ho riserve di principio; ho riserve di praticabilità. Sarei per soprassedere: cerchiamo ora di far funzionare bene il sistema. Ci sarà modo di far valere, anche con rimostranze, che una questione dichiarata “non manifestamente infondata” è poi stata accolta in un altro procedimento. Forse a volte filtriamo troppo, e si aprirà un dibattito su questo tema. Affronterete un problema simile all’articolo 6: “delimitare il ricorso ai decreti legge ai soli casi di necessità e urgenza effettivi”. Capisco l’intento e la volontà di restringere l’abuso, ma temo che non passi per le parole. Possiamo scrivere “necessità” o “assoluta necessità”: l’interprete, secondo convenienza, distinguerà tra necessario e assolutamente necessario. Quanto si può stringere più che dire “necessità e urgenza”? In Italia sta succedendo di tutto: si afferma la necessità e urgenza perché lo dice la maggioranza, ma non può funzionare così. Deve intervenire il giudice costituzionale: domani potrebbe intervenire il Collegio Garante per un conflitto di attribuzioni dovuto a un uso improprio del decreto legge. Perciò la mera asserzione tautologica della necessità va censurata con i controlli tra poteri, non con aggiustamenti nominalistici. Sul piano procedurale, si potrebbe introdurre l’istituto dell’amicus curiae: la possibilità di intervento, in questioni sollevate, di soggetti qualificati ed esperti. Ovviamente con filtri, per evitare abusi e ammettere solo chi dimostra di poter offrire un apporto utile. È un arricchimento del contraddittorio davanti all’organo di costituzionalità. L’importante è che tra l’organo che giudica le leggi e l’organo che le fa ci sia sempre un dialogo istituzionale vero, non solo proclamato. È un meccanismo di dialogo, ciascuno nel rispetto delle proprie prerogative: né condizionamenti, né invadenze, ma collaborazione. Uno sguardo alle altre competenze. In prima battuta il Collegio Garante aveva raccolto molte competenze, con l’intesa che poi sarebbero state traslate ad altri organi della giurisdizione ordinaria. Segnalo che, quando trasferite la competenza, conviene trasferire anche una procedura ad hoc. Oggi la disciplina processuale è rimasta nella legge 55/2003, cambiando solo il giudice competente. Ma la procedura? Forse è il caso di prevederne una più specialistica, modulata sull’organo che decide. So che è stato osservato che attribuire al Collegio la massima autorità, cioè la pronuncia sugli appelli in materia disciplinare, significa garantire una collegialità qualificatissima rispetto a una decisione già emessa in sede collegiale dal Consiglio Giudiziario. Mi si concederà però che, se si vuole ristrutturare e ridisciplinare la procedura disciplinare, non mancherà modo di prevedere un itinerario diverso, in cui ci sia una pronuncia monocratica e un controllo successivo, come in molte materie della giurisdizione ordinaria. È difficile sostenere che non ci possa essere un giudice ultimo di terza istanza in materia disciplinare, mentre può esserci quando si giudica un ergastolo o trent’anni di reclusione. È una situazione singolare. Detto questo, mi rendo conto che un’eccezione bisognerà pur prevederla: come in materia di astensione e ricusazione, quando a doversi astenere o a subire il procedimento disciplinare è un organo di vertice — il giudice dei rimedi straordinari — che non ha nessuno sopra di sé, e lì, come avviene appunto per l’astensione o la ricusazione, non può che essere il Collegio a giudicare. Ma solo lì è necessitata, secondo me, la competenza del Collegio: quando deve giudicare le espressioni apicali dell’ordinamento, come è competente a giudicare i Capitani Reggenti. È un compito particolarmente oneroso, certo, ma non può svolgerlo un magistrato ordinario. Quando si tratta di giudicare questioni di astensione, ricusazione o presunti illeciti disciplinari di magistrati apicali, sì, ma questo significa passare dall’ordinarietà all’eccezionalità di una competenza che attualmente crea non pochi imbarazzi al Collegio. Comunque, anche se — dal mio punto di vista — inopportunamente rimanesse, è necessario disciplinare meglio il procedimento, perché l’attuale normativa dice: “Si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.” Ora, siamo tutti abbastanza esperti per sapere che “in quanto compatibili” è l’espressione che usa il legislatore quando non sa cosa dire. Così si scarica sulla giurisdizione ciò che il legislatore non ha voluto o saputo fare. Quindi è opportuno che si disciplini puntualmente questo procedimento, se anche dovesse rimanere. Riguardo al sindacato sui Capitani Reggenti, è stato osservato che c’è un difetto di tassatività sotto il profilo sanzionatorio. Le vecchie Statuti parlavano di “inabilitazione” ma senza limiti temporali. L’avvocato Selva ha osservato che questo è al limite dell’esigenza di tassatività. È vero che la parte deve precisare qual è la condanna richiesta, ma non può essere la parte a determinare la risposta sanzionatoria per una determinata condotta. Sono tutte sanzioni interdittive, ma dovrebbero essere meglio definite. Anche in materia di referendum è opportuno, perché ci sono oscillazioni giurisprudenziali, introdurre una definizione più puntuale dei requisiti di ricevibilità. Ci sono state pronunce in cui è stato difficile individuarli, e fatalmente questo comporta piccoli sbandamenti o errori: è la difficoltà di dare un significato univoco a norme che ne difettano a priori. Allora, a seconda delle sensibilità e delle esigenze, si tende a dare contenuti differenti. Sempre in un’ottica di collaborazione istituzionale, di reciproca fiducia nel dibattito pubblico, volevo rappresentarvi anche un’esigenza a cui, in verità, il Collegio potrebbe ottemperare da solo, ma preferisco sottoporvela per un eventuale dibattito o suggerimenti critici. Abbiamo condiviso la necessità di istituire un referendario, cioè un assistente giuridico del Collegio, perché non possiamo coprire tutti i settori scientifici: le nostre competenze, almeno le mie, sono limitate, e qualche volta sarebbe utile avere supporto tecnico. Avevamo parlato anche con il direttore dell’Istituto Giuridico, in modo da interloquire su questo. Ma, ancora più importante, credo sarebbe costituire un ufficio stampa presso il Collegio, perché rappresenterebbe un prezioso collegamento con la collettività. Invece di leggere versioni urlate o polarizzate, a seconda della sensibilità politica del momento, un ufficio stampa potrebbe esporre in modo sobrio e sintetico la decisione e le sue ragioni essenziali. Questo, secondo me, favorirebbe un avvicinamento della cittadinanza all’attività del Collegio, che oggi per molti rimane oscura o percepita solo attraverso il sensazionalismo mediatico. L’augurio, comunque, è che voi possiate lavorare seguendo il principio che diceva Vittorio Foa: secondo cui anche la migliore delle tradizioni si serve soltanto rinnovandola. Però su questo vorrei essere chiaro: rinnovandola, sì, ma come fa la pianta epifita. La pianta epifita è quella che cresce sopra un’altra pianta — non è parassita — si appoggia, come si diceva un tempo, sulle spalle del gigante. Il passato vostro è un gigante di notevoli dimensioni: ci si deve appoggiare su quelle spalle, crescere usando come sostegno ciò che già esiste, e non, come avveniva nella monumentalistica antica, distruggere i monumenti per recuperarne marmi e pietre. Perché così si perde la storia e si distrugge ciò che di valido era stato creato. Bisogna andare oltre, con miglioramenti progressivi, successivi ed equilibrati.
Enrico Carattoni (RF): La mia riflessione, o meglio lo stimolo su cui volevo chiederle un suggerimento, è questo: il Collegio Garante, fra i vari organi che noi ci troviamo ad analizzare o, se possibile, a contribuire a migliorare, è certamente quello di più recente istituzione. Se lo paragoniamo al Consiglio Grande e Generale o anche al Congresso di Stato, è un’istituzione giovane. E, come abbiamo avuto modo di affrontare anche con l’avvocato Giovanna Crescentini, il Collegio vive ancora sulle spalle della sua prima norma istitutiva, quella del 2003, che doveva essere sostanzialmente di natura transitoria, anche per le attribuzioni che al tempo gli venivano assegnate: quindi, il ruolo di giudice dei rimedi straordinari, di giudice in parte di terza istanza, tutte competenze che oggi sono venute meno. Dall’altro lato, invece, sono state attribuite altre competenze di maggior rilievo. In particolare c’è il tema della questione disciplinare dei magistrati, che se prima era già prevista con la legge del 2003, che poi si intersecava con la 144 e la 145, oggi ha una rilevanza diversa, perché funge sostanzialmente da giudice d’appello rispetto a certe questioni disciplinari dei magistrati. La prima domanda è dunque questa: a fronte di questa innovazione intervenuta dal 2021, nella sua esperienza, ritiene che vi siano dei correttivi che possano essere apportati a questa disciplina? Rispetto alla disciplina previgente, dove era il giudice monocratico supplente a curare l’istruttoria e un giudice monocratico effettivo a curare la parte decisionale, oggi ci sono questioni che possono generare qualche tipo di problematicità, visto il ruolo collegiale? E ritiene che questa competenza, nella sua formulazione attuale, sia correttamente disciplinata, oppure servano dei correttivi? La seconda domanda riguarda invece il ruolo cardine del Collegio Garante, cioè quello del sindacato di costituzionalità. Come detto anche poco fa, secondo la Dichiarazione dei Diritti nella sua riforma e secondo la legge 55 del 2003, il sindacato di costituzionalità doveva essere il fulcro delle competenze del Collegio Garante. Il livello di dettaglio con cui è stato disciplinato faceva desumere che fosse il centro della sua attività. Oggi, però, e questo non per colpa vostra ovviamente, si vede che in realtà le pronunce tipiche di sindacato di costituzionalità sono numericamente più esigue, non solo rispetto al passato, ma anche rispetto ad altre competenze che nel tempo sono state attribuite. Capisco che, come lei diceva, prevedere un ricorso diretto del singolo cittadino, sarebbe forse eccessivo. Mi chiedo però quale possa essere un modello per rinvigorire questo tipo di attività. Come lei ha accennato, c’è stata una riflessione sul tema della rilevanza nel giudizio a quo e anche della non manifesta infondatezza: forse, quest’ultima potrebbe essere un vaglio che attiene più direttamente al Collegio. Dall’altro lato, credo che la percezione sia che i ricorsi stiano aumentando. E temo che questo sia un tema che chi fa politica non può ignorare. Credo che tutto questo potrebbe essere, almeno in parte, limitato se ci fosse un accesso più certo, pertinente e facilitato al Collegio Garante.
Professore Glauco Giostra: Io credo che, nei compiti della Corte Costituzionale non possa esserci quello di condannare nel merito, perché presuppone un’altra competenza, un’altra sensibilità e anche un’interconnessione con un mondo che deve rimanere invece distante, ma in dialogo e in interlocuzione costante per le rimessioni e per tutto il resto. Io ho lavorato qui, per San Marino, a un progetto sulle intercettazioni, abbiamo fatto anche un bel convegno, e forse anche su quella scia, dopo, mi è stato chiesto se volessi entrare nel Collegio. Io dissi: “Non voglio giudicare i miei simili, non ne sono capace, lo soffrirei molto.” Trovarmi a dover pronunciare nei confronti di persone incolpate di qualcosa mi crea disagio. Credo che non sia compito del Collegio e che andrebbe ricondotto a prerogative qualificate e selezionate per un collegio di tal fatta, quindi al sindacato di costituzionalità. Quello che dovrebbe essere il compito principale, elettivo, diventa uno dei compiti, e tutto si concede insieme ad altri. Questo mi sorprende molto, e forse ha ragione quando dice: “Allora bisogna fare qualcosa.” Io ho detto prima: lasciamo ancora del tempo, magari la pressione del mondo forense sui giudici di merito porterà, anche attraverso esempi e confronti corretti e leali, a una maggiore consapevolezza. Uno può, in qualche modo, debitamente o forzatamente, sensibilizzare. Ma se questo non bastasse, io penso che una delle strade sia proprio quella che lei ha acutamente indicato: cioè, il giudice a quo è l’unico che può dirmi se la pronuncia richiesta è rilevante, perché è lui il dominus del processo, lo conosce meglio; inutile che noi proviamo a ricostruire dall’esterno. Credevo si potesse farne a meno, ma se la situazione che mi rappresentate è così insistita, non ho dubbi che sia fondata su una realtà che tende a perpetuarsi e consolidarsi. Se demandiamo al giudice a quo solo il giudizio sulla rilevanza, probabilmente passerà molto di più, perché non potrà negare che, se cade quella norma, qualcosa cambia in quel processo. E quindi, che lo ritenga o meno, la questione arriverà al Collegio, e si allargherebbero le maglie del filtro.
Massimo Andrea Ugolini (PDCS): Facendo riferimento anche all’audizione che abbiamo avuto prima di lei, il professor Guidi ci ha posto il problema di come molto spesso le stesse soluzioni o gli stessi intendimenti che possono essere valutati quando si interviene su paesi grandi rispetto a paesi piccoli devono essere contemperati da un approccio differente. Infatti, molto spesso non si può adottare lo stesso metodo, perché le criticità, pur con lo stesso obiettivo finale, si manifestano in modo diverso e richiedono modalità di intervento non necessariamente analoghe. Ed è per questo che, facendo riferimento anche al quesito sollevato dal collega Carattoni, sul fatto che il Collegio Garante sia anche giudice nei sindacati della Reggenza o nelle questioni disciplinari dei magistrati, credo che questo si spieghi anche per una ragione strutturale: come abbiamo detto in diversi convegni dedicati anche agli anniversari del Collegio Garante, a San Marino il Collegio Garante è sì Corte Costituzionale, ma anche giudice di merito. La legge del 2003, e in particolare l’ultima modifica introdotta con la legge costituzionale del 2021, attribuisce al Collegio, per esempio, la competenza in qualità di giudice d’appello per i giudizi disciplinari dei magistrati. Se andiamo indietro alla legge del 2013, addirittura in forma monocratica vi era una distinzione di fatto, perché non erano neppure previste sanzioni intermedie per i magistrati. Questo perché, in un piccolo Stato come il nostro, trovare giudici che siano in ogni momento imparziali rispetto a una serie di procedimenti non è sempre facile. Bisogna quindi contemperare l’indipendenza con la necessità di trovare soluzioni che garantiscano anche l’economicità e la speditezza del procedimento. In questo senso, ad esempio, oggi il giudice di primo grado è il Consiglio Giudiziario, mentre il Collegio Garante funge da giudice d’appello. In precedenza, invece, per i giudizi disciplinari, il Collegio Garante operava in forma monocratica: una configurazione molto diversa da quella attuale. Condivido, Presidente, quanto lei ha osservato circa la differenziazione tra giudice effettivo e giudice supplente. Credo che, con l’attribuzione di competenze e la complessità che il Collegio ha oggi, questa distinzione non sia più corretta. Ritengo opportuno, nel momento in cui si procederà a una rivisitazione o rivalutazione della composizione del Collegio Garante, iniziare a ragionare su un organo formato da giudici tutti effettivi, o comunque da membri aggiunti che abbiano piena effettività in tutte le decisioni da affrontare. Sarebbe utile, inoltre, introdurre competenze specifiche per alcune materie particolari, come i giudizi disciplinari o il sindacato sulla Reggenza. In questo modo si darebbe maggiore omogeneità ai componenti del Collegio, si valorizzerebbe il ruolo di ciascuno e si rafforzerebbe la funzionalità complessiva di questo importante organo costituzionale. Allo stesso tempo, credo sia necessario dotare il Collegio anche di strumenti procedurali aggiornati, per una migliore organizzazione e una maggiore efficienza delle sue attività. Concludendo, condivido pienamente che un intervento sul tema della distinzione tra giudice effettivo e giudice supplente vada fatto, e credo anche in tempi piuttosto rapidi.
Professore Glauco Giostra: Lei ha toccato tre temi: il rapporto tra medesimi problemi nel grande Stato e nel piccolo Stato, il procedimento disciplinare e la composizione dell’organo collegio giudicante. Sull’ultimo è d’accordo con me, quindi è inutile che interloquisca. Sulle altre due questioni, invece, una piccola postilla: sulla prima per condividere pienamente e dimostrare concretamente come si possano atteggiare questi problemi; sulla seconda, come ho già detto, non siamo d’accordo. Proverò a dire qualcosa in più, ma non siamo d’accordo. Bisogna prendere atto che abbiamo posizioni diverse. Allora, grandi Stati e piccoli Stati: medesimi problemi, diverse ricadute. E se vogliamo fare un esempio concreto, per non rimanere nell’empireo della teoria: pensate al contesto ambientale che può far sospettare che il giudice non sia più sereno, per il clamore suscitato dalla vicenda, per condizionamenti mediatici o per movimenti popolari. In uno Stato di grandi dimensioni, come in Italia, esiste — o meglio, esisteva, perché oggi funziona poco — l’istituto della rimessione, e così da Catania si sposta il processo a Torino. A Torino non ci sarà quella particolare sensibilità rispetto ai temi di mafia o traffico di stupefacenti, perché lì si parla d’altro, e quindi la collettività è più distante dal problema. A San Marino, invece, questo non si può fare. Dove vai? Quindi San Marino richiede soluzioni diverse per lo stesso problema. Come diceva lei, la soluzione potrebbe essere — ad esempio nei casi più delicati — quella di rivolgersi a un giudice esterno, qualcuno che venga da fuori e non risenta del contesto ambientale, ovviamente nei casi eccezionali, perché non è che si possa sempre fare ricorso a questa modalità. Questi sono i due profili. Sull’altro, invece, non siamo d’accordo. Io faccio fatica a capire per quale ragione, nel procedimento disciplinare, ci sia bisogno di una collegialità in prima battuta, in appello, mentre per infliggere sanzioni di trent’anni di reclusione basti un giudice monocratico, con il controllo di un altro giudice monocratico. Non riesco a capirlo, ma probabilmente è un mio limite. Io, invece, riserverei la collegialità alta del Collegio ai casi delle cariche apicali, cioè a procedimenti di vertice. Anche perché, non a caso, negli altri ordinamenti, quella competenza non viene assegnata alla Corte Costituzionale, ma alle Sezioni Unite della Cassazione.
Iro Belluzzi (Libera): Ritengo che la politica abbia già fatto un passo avanti rispetto a esigenze che da tempo vengono manifestate dal Collegio Garante, in particolare su quella che dovrà essere, e spero venga superata in tempi brevi al termine dei lavori della Commissione, la distinzione tra membro effettivo e membro supplente. Si potrebbe pensare, logicamente, anche a specializzazioni interne, ipotizzando, ad esempio, due sezioni, in base alle diverse competenze che derivano dall’impegno che il Collegio ha nell’occuparsi dei giudizi disciplinari verso i magistrati. Spero che su questo punto si apra un dibattito serio, perché è un tema che da tempo si discute anche all’interno della politica, e credo che siamo finalmente giunti al momento di affrontarlo concretamente. Un elemento che potrebbe essere nuovo anche per la Repubblica di San Marino — non so se percorribile, ma è in discussione nella Commissione Affari di Giustizia — riguarda il superamento del giudice monocratico, almeno per quanto concerne il giudizio finale, cioè il terzo grado, nell’amministrazione della giustizia penale. Ecco, la domanda che le rivolgo è questa: secondo lei, anche all’interno del Collegio Garante, il grado finale di giudizio potrebbe divenire collegiale, mentre nei gradi precedenti potrebbe restare monocratico?
Professore Glauco Giostra: L’esigenza minimale è che non passi più questa idea, più o meno esplicitata, che ci siano giudici di Serie A e di Serie B. Questo non permette di lavorare serenamente. Io l’ho percepito. E, ripeto, queste dimissioni che si stanno registrando sono la dimostrazione di un certo disagio funzionale. Quanto alla collegialità finale degli organismi, certo che sarebbe auspicabile tuttavia la collegialità del giudicante è sempre un valore aggiunto prezioso. Noi siamo arrivati con molta fatica, anche in Italia ma non solo, a valorizzare il significato del contraddittorio: accusa e difesa, attore e convenuto. Ecco, la collegialità non è altro che portare il contraddittorio all’interno della camera di consiglio, dove non c’è solo il monologante che decide da solo. Quindi sì, è utilissimo. Due sole osservazioni. La prima: non so se, dal punto di vista strutturale, San Marino possa permetterselo. Non sono in grado di valutare se un organo collegiale possa funzionare in modo sostenibile, magari selezionando molto i casi o filtrandoli, perché altrimenti il carico di lavoro diventerebbe ingestibile. Si potrebbe prevedere la collegialità come eccezionale o a composizione occasionale, mettendo insieme giudici che, però, abbiano anche esperienze e competenze diverse, anche monocratiche. Non so, questo spetta a voi, ma certamente mi trova d’accordo sul principio. Per quanto riguarda la possibilità, all’interno del Collegio Garante, di prevedere una prima fase con un giudice monocratico e poi una decisione collegiale, ho una riserva non giuridica, ma pratica. Ha ragione lei, non è una questione astratta, ma concreta: si creano situazioni imbarazzanti. Non la vedo, dal punto di vista pratico e psicologico, come una soluzione particolarmente convincente. Sotto il profilo tecnico-giuridico, invece, sì: il collegio conferisce sempre un valore aggiunto.